ESTATE 2018
E rieccoci con il solito problema: i ragazzi leggeranno quest'estate? Qualcuno mi ha già fatto giungere indirettamente, le sue querimonie: quattro (tre, sei, sette, il numero non importa) libri, sono troppi! Troppi per che cosa? Lascio la domanda in sospeso, chissà se un giorno qualcuno riuscirà a rispondere... Io credo di no.
A seguire le mie letture, rigorosamente in ordine cronologico inverso, ovvero dalla più recente fino alla prima di questa estate. C'è un bel po' di storia, perché, si sa, una volta che si assaggia qualcosa di buono vien voglia di provare di nuovo...

Un titolo di divulgazione, senza altra pretesa: ma è gradevole, a offre alcuni spunti che poi, se si vuole, possono essere indagati più in profondità. E' ovvio che se si trattasse di una conversazione radiofonica la forza attrattiva dei contenuti sarebbe ancora più incisiva, ma e' sufficiente riconoscere che pur non essendo un libro geniale è un libro interessante.

Il volume non è che il resoconto di un corso universitario riproposto dal prof. Chabod tre volte, l'ultima a un anno dalla morte avvenuta nel 1960. Manca il riferimento a molti studi successivi, quando finalmente l'Europa come unità economico-politica compì i primi passi; manca anche di una riflessione che vada oltre il i testi del Guizot scritti intorno al 1830, come se i successivi nazionalismi non abbiamo minato o per lo meno modificato quell'idea che sembrava, da Machiavelli in poi, aver attecchito ed essersi sviluppata con tratti comuni pur nel progressivo svilupparsi della cultura, della politica e della società prima rinascimentali, poi secentesche, poi illuministiche e infine romantiche. Resta comunque un saggio con indicazioni e citazioni puntuali di alcuni dei più autorevoli pensatori europei (per l'appunto!) dal secolo XVI all'inizio del XIX. Ciò che colpisce sono soprattutto alcune suggestioni che sembrano scritte per i nostri giorni: come le considerazioni dello stesso Guizot sulla fiacchezza morale degli italiani, che si traduce in una (sconfortante) mancanza di fede nella verità.
L'interrogativo a cui Chabod risponde implicitamente, senza averlo mai pronunciato veramente, è che l'Europa ha una sua unità concettuale, sociale, politica, religiosa, identitaria; e che tale unità risponde a un principio sotteso, che "sente come figli suoi quelli che non sono ricevono,ma danno, quelli cioè che assorbono dall'eredità comune ma per contribuire, a loro volta, con nuovi acquisti di alto pensiero morale e di cognizioni scientifiche o di creazione poetica." E per questo il sentimento europeo è costituito da volontarismo e non da naturalismo: per la preminenza data ai fattori morali e culturali, allo spirito scientifico e de société: "il senso europeo è un senso di solidarietà morale e di connessione spirituale, non di solidarietà razzistica."
Parole scritte, queste ultime, in occasione corso tenutosi all'Università di Milano nell'anno accademico 1942-43: lascio a chi legge le inevitabili considerazioni del caso.

Un saggio interessante, a tutto tondo: la vicenda medievale dei templari occupa poco più due terzi delle pagine, mentre le altre sono tese ad indagare quando e come rinacque, a partire dal Rinascimento, l'interesse per l'ordine religioso cavalleresco. Ciò che più colpisce della storia dei Pauperes commilitones Christi è la loro modernità: già nel XII e XIII secolo svolgevano funzioni proprie della banca, cioè custodire denaro e preziosi per conto di ricchi cavalieri e principi, emettere lettere di credito, prestare denaro. Fu certamente il loro ruolo, così atipico eppure così apprezzato e supportato da una figura autorevole come Bernardo di Chiaravalle, che li inimicò agli occhi di molti: per il loro eclettismo, la loro capacità di mediazione diplomatica (altro che soli monaci guerrieri!), la loro autorevolezza. E altresì stupisce la modernità del processo che portò allo scioglimento dell'Ordine, all'ergastolo per molti degli ex monaci e al rogo dei suoi massimi esponenti. Un metodo di accusa basato sulla macchina del fango e sulla contaminazione delle prove, nonché sull'intimidazione dell'autorità papale da parte di quella politica (il re Filippo il Bello, che voleva a tutti i costi mettere le mani sul cospicuo patrimonio templare). Allora un papa avignonese ostaggio del re francese decise, contravvenendo alle promesse sacre, che era meglio aver salva la vita piuttosto che l'anima. L'esortazione del "date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio" è sempre stata vanamente pronunciata, ieri come oggi.
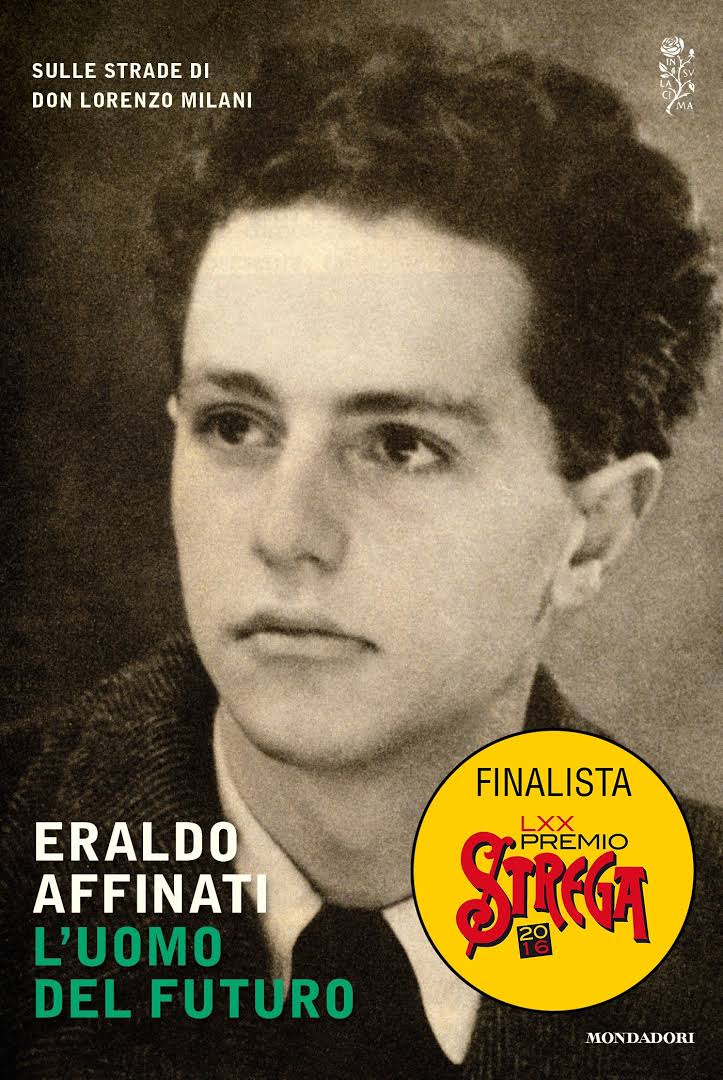
Doverosa una premessa da parte della sottoscritta: lessi Lettera a una professoressa a 12 anni, dopo aver trovato tra i libri di casa una copia del volume con la classica copertina bianca. Nel corso degli anni successivi, al liceo, ho letto più volte Esperienze Pastorali, le lettere del priore di Barbiana, la Lettera ai cappellani militari e quella Ai giudici, e tanto altro ancora. Erano testi che leggevo e rileggevo, fascinata dalla dirompente energia di quel prete-educatore che non aveva mezze misure e non faceva sconti a nessuno (tanto meno a se stesso). Tenevo Don Milani come riferimento durante gli anni dell'Università, nella seconda metà degli Anni Ottanta. La Facoltà di Lettere dell'Università di Pavia e il vicino Collegio Ghislieri erano ambienti persi nei rigori filologici e abbracciati a una tradizione accademica presuntuosa, del tutto avulsa dalle riflessioni dirompenti sulla lingua come strumento egualitario. Venni additata, da docenti e compagni, come una stordita che tralasciava i fondamenti della linguistica, della letteratura, dell'impegno dottorale, per cose inconcludenti, superate dal farsi degli studi e degli eventi, e lontane dalla necessità accademica. Naturalmente la mia convinzione ha avuto un prezzo, anche salato: ma, a distanza di anni, non mi dispiace affatto averlo pagato, e pour cause. In tutto questo tempo i libri e su don Milani non mi hanno mai abbandonato: la sua figura mi è stata d'aiuto, di sprone, di conforto, talvolta anche esempio critico da non imitare ma su cui ragionare.
Scusatemi per la lunga introduzione, che forse potrebbe sembrare fuori luogo; serve tuttavia per lasciarmi dire che ho frequentato don Milani quel tanto che basta per poter definire il libro di Affinati un'opera di cui, a partire dal titolo, tutto appare sfuocato e molto spesso pretestuoso. L'uomo del futuro è l'autore stesso? Perché di don Milani non si ha un ritratto, né una biografia, né un colloquio postumo che avrebbe potuto almeno costituire un ben più solido banco di prova per il lettore e le sue (in)certezze: no, Affinati usa la seconda persona per parlare a sé stesso e di sé stesso. Ad alcuni sfrangiati ricordi su Lorenzo Milani e sul priore di Barbiana seguono inserti su esperienze di viaggio che, nell'intenzione dell'autore, dovrebbero essere echi riflessi della lezione sottesa di don Milani, che preconizzava una società multi-etnica, priva di barriere, fondata sull'impegno civile in grado di educare al riscatto dei poveri e degli emarginati. Tutto inutile: il racconto personale diviene preminente, e la figura di don Lorenzo Milani risulta spesso incomprensibile, abbozzata com'è in un diario autoreferenziale.
Di questo libro si salvano solo alcune parti: l'ultimo capitolo, una cronaca implacabile di come la Chiesa possa tradire sé stessa, chiusa nei suoi giardini tirati a lucido; qualche riflessione pedagogica con le citazioni del gesuita francese De Certau; il commento dedicato a quell'affermazione coraggiosa di don Milani quando dichiara, in tempi di severa sofferenza morale e fisica, che "anche la scuola deve tendere tutto nell'attesa di quel giorno glorioso in cui lo scolaro migliore le dice: 'povera vecchia, non ti intendi più di nulla', e la scuola risponde con la rinuncia a conoscere i segreti del suo figliolo, felice solo che il suo figliolo sia vivo e ribelle."
Come si dice, prendiamoci il buono che c'è; ma per frequentare don Milani la strada è un'altra.

Opera che quest'anno compie i 40 anni ma che sa accendere le giuste luci - mai accademiche - sulla figura di un uomo che seppe unificare l'Europa sotto i sigilli della fede e della cultura (sì, proprio lui che era quasi analfabeta!). In tale impresa l'eccezionalità di Carlo Magno sta nel fatto che fu secondo ai Romani e mai più seguito da altri. Granzotto ci offre un ritratto del personaggio storico sfumato nei e dai propri sentimenti di scrittore. In quelle parti è legittimo, per chi legga il testo come un mero saggio storico, avvertire fastidio e retorica: ma il libro di Granzotto non è un saggio storico, ma è piuttosto il reportage di un valente corrispondente di guerra e di cronaca dal secolo VIII d.C.
Libro scoperto per caso in una biblioteca della Val di Sole, e che nella sua brevità (sono 140 pagine, seppur fitte e con carattere piccolo) per larghi tratti non è per niente agile: a dimostrare che una storia fitta di Alahis, Ansfrit, Rodempert, Cuninperga, Gisenperga, Gumperga, Garibaldo, etc etc, etc., e infiniti e avviluppati accadimenti di alleanze, tradimenti, battaglie, matrimoni, parentele, figliolanze, dichiarazioni di inimicizia, ribaltamenti. invidie, gelosie, e anche qui etc etc etc, risulta essere alle nostre menti e alle nostre orecchie convulsa e confusionaria. Certo è che il popolo longobardo rimane un unicum nell'Europa dell'Alto Medioevo, ed è degno di nota, come sostiene l'autore, osservare che senza di loro probabilmente non sarebbe nato il Regno di San Pietro. Ma ciò che più meraviglia è la sottesa insinuazione che abbiano lasciato la Pannonia affascinati da una terra dove la Storia era stata scritta da un popolo, quello romano, che li affascinava più di quanto potessero loro stessi credere, e di cui non riuscirono a riprodurre la solida struttura statale. Se non resistettero che per poco più di duecento anni, la ragione stava (oggi la circostanza assume il tono di un sinistro presagio) proprio nel loro essere poco Stato e molto clan, in un perpetuo rivolgimento di fronte tra fazioni interne: pronte ad allearsi con i nemici di fuori pur di estirpare il fratello vicino.

Se qualcuno ha per caso ipotizzato che il prossimo anno avrò classi con cui affrontare il Medioevo, beh, ci ha visto giusto. Ma quando si leggono certi libri, il piacere di scorrere le pagine è impareggiabile: e intanto anche quello di fermarsi e commentare che si poteva scrivere meglio, o peggio, o che quanto si legge non serve a nulla, o che si vorrebbe buttare il libro dalla finestra; oppure si corre su IBS per comprarne subito una copia da tenere devotamente sullo scaffale.

Per quest'opera di Cardini vale ex contrario quanto detto a proposito del prof. Barbero: lavoro dove la sapienza accademica e la ricerca preziosa (non è un volume divulgativo, almeno di primo acchito) si avvertono. Perché dunque non premettere una lista dei personaggi citati e qualche mappa storico-geografica in più? Per interi passaggi, soprattutto nelle pagine iniziali, gli eventi della Guerra dei Cent’anni e le vicende legate al trono i Francia diventano una ragnatela vischiosa, in cui ci si potrebbe smarrire facilmente. Ma così si perderebbe il racconto del processo, che Cardini ricostruisce attingendo ai verbali, con i quali ci fornisce una narrazione più interessante delle gesta della santa guerriera. E, in effetti, ciò che rimane è il senso di mistero, interesse e fascino che emana dalla vicenda: dove alla ragion politica si sovrappone quella religiosa e, soprattutto, quella di una storia che si dipana con i suoi paradossi e il suo fascino sottile.

Il prof. Barbero è conosciuto come un divulgatore televisivo di successo, e questo dovrebbe mettere in guardia visto il livello della nostra TV. Per lui invece faccio un'eccezione: sa portare nelle case argomenti e contenuti con la semplicità e il garbo di chi non pretende di "essere facile", bensì intende esortare a capire la complessità senza timori. Durante la lettura si ha l'impressione che l'autore ti tenga una mano sulla spalla e ti sorrida mentre spiega e racconta. Non ha paura di ripetersi, qua e là: sa che repetita iuvant, e ce lo dice apertamente mentre ritorna a citare una cronaca o il passo descritto qualche pagina prima.

Insomma, il prof Barbero sa raccontare benissimo la storia; in questi libri, che non hanno l'odore dell'accademia ma quello della vita di tutti i giorni, si impara il Medioevo con interesse. Appassionanti i ritratti di Salimbene da Parma e Dino Compagni; affascinante il discorso sulle crociate; intriganti le pagine su Caterina da Siena e Christine de Pizan. Questi libri sono come le ciliegie: uno tira l'altro, e non smetteresti mai di leggerli.
Bisogna contare le parole per parlare di quest'opera, per non rischiare di restare eccentrici rispetto all'intensità profonda e sobria del romanzo, uno dei più belli di ogni tempo. Come si fa a non restare accanto al tenente Giovanni Drogo, a riconoscersi nel suo struggimento silenzioso? Con una prosa altrettanto sobria e magnifica nella sua lineare chiarezza, l'allegoria di una vita e della Vita acquista forza pagina dopo pagina. Una lezione di intelligenza, di onestà, di stile.

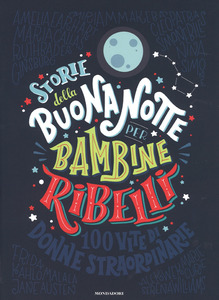
Successo editoriale importato dall'Inghilterra, scritto in inglese da italiane che forse qui in Italia non avrebbero avuto altrettanta eco. A dire il vero, nel leggere queste pagine viene nostalgia degli exempla medievali; mutatis mutandis, la quantità non garantisce la qualità, e se di storie si deve parlare bisognerebbe anche riconoscere che non sempre la buonanotte è assicurata, non so se per un problema di traduzione, gusto o accanimento edulcorante. Ecco come viene riduttivamente descritto il fascismo: "L'Italia era governata da un tiranno chiamato Benito Mussolini. Durante la dittatura di Mussolini, non si potevano leggere certi libri, non si potevano guardare certi film, non si potevano esprimere le proprie opinioni e non si poteva votare" . Vi rimando anche al cenno sull'apartheid. Un libro per i bambini non significa scegliere di scrivere in modo banale e semplicistico, soprattutto se poggia su una certa aspirazione etica.

So che qualche mio alunno mi manderà una gran quantità di maledizioni arrancando nella parte centrale di questo romanzo breve, ma per cominciare a parlare di arte bisogna pur affrontare qualche fatica. Il rapporto letterato/borghese è, in filigrana, uno dei motivi portanti del Novecento, e da lì non si scappa. Mann ne fa una questione di nostalgia, di invidia per il ceruleo orizzonte del buon senso solido e concreto, privo di ripensamenti e inquietudini. Ma, alla fine, chi vince è l'inquietudine: con i Buddenbrock Mann aveva cantato l'epopea della decadenza, e l'aveva interpretata in modo magistrale. Con Tonio Kroger il tema è ripreso con un certo impaccio teorico (è pur sempre un romanzo breve), ma alcune pagine sono comunque piccoli capolavori letterari, come la passeggiata con Hans, il ballo del Kroger adolescente e il non-ballo del Kroger adulto.

Balzano è arrivato a Curon nel 2014, io nel 2001, quando il Sudtirolo era meta trascurata dagli italiani, soprattutto la Val Venosta. Anch'io ho la fotografia di rito, mentre, abbracciata al coniuge, sullo sfondo c'è il campanile semisommerso. La violenza e il delirio di questa storia è per molti versi simile a quella del Vajont; solo che là non era preceduta, come qui, da una violenza ancora più crudele, quella di un'italianizzazione forzata che colpì le vite dei sudtirolesi fin dal più profondo dei sentimenti, quello della lingua madre. La ferocia e l'ottusità stupida di gente come Eva Klotz si spiega (non si giustifica) con un passato simile (per la cronaca: Eva Klotz, dimenticate le sue battaglie pseudoindipendentiste, si gode il vitalizio tutto italiano: in Austria avrebbe ricevuto un trattamento molto meno generoso).
Scrivo tutto ciò, apparentemente off topic, perché il libro di Balzano a questo chiama: a riflettere sull'attaccamento a qualcosa, a qualcuno, e persino alla vita. Se si smetta di vivere quando non c'è più volontà di restare attaccati a ciò che ci circonda resta una domanda sospesa, e del resto la risposta non ci interessa: ciò che vediamo è la storia di una famiglia di contadini che non sono né buoni né cattivi, e che a a loro volta restano sospesi tra l'andare e il restare.
Il finale della cronaca è noto, sta ritratto nelle foto del Lago di Resia; quanto al resto, la delicatezza dell'autore nel descrivere gli affetti e le emozioni. ne fa un romanzo degno di nota. Probabilmente è questo il libro che dovrebbe vincere lo Strega, anche per offrire al pubblico il racconto di una storia su cui spesso gli italiani, compresi i nostalgici, non si sono ancora confrontati con la necessaria onestà.

Talvolta penso se potrei mai consigliare ai miei studenti un libro di Bernhard. La risposta è sempre, invariabilmente, negativa: fanno già troppa fatica a leggere alcunché, figurarsi una prosa controversa come quella dell'autore austriaco, che nell'ossessività delle sequenza sintattiche scrive la sfiducia verso la Storia e la Scienza. Bernhard rigettava senz'altro le magnifiche sorti e progressive, e con esse la retorica delle premiazioni, dei ritrovi mondani e delle ragioni di convenienza; salvo non disdegnare, come lui stesso spiega, la pecunia che derivava da quel balletto di mondanità ottuse. Nel pugno allo stomaco di certi passaggi bernhardiani sta invece, come ho già scritto, un attaccamento disperato alla vita, e quindi il disprezzo per chi della vita comprende solo il significato superficiale e disonesto.
Il libretto è godibile e divertente. Viene da domandarci, se mai avessimo avuto la possibilità di incontrare gli autore, quali dettagli ci abbia taciuto in alcune scene memorabili, come quella in cui il ricevimento viene annullato. L'altra domanda che affiore alla mente ogniqualvolta si chiude un libro di Bernhard è se l'Austria (cioè il mondo) di oggi abbia capito quanto è pericoloso tenere al caldo la propria ottusità.

Chi si è cimentato con le "Vite parallele" di Plutarco? Nel libro vengono riproposte, secondo una linea temporale-cronachistica, le vite degli uomini illustri che hanno segnato la storia greca e romana. Un buon spunto per ripassare le vicende di quei secoli, e per saperne di più sui nomi degli eroi che hanno scritto imprese gloriose e disastri rovinosi.
Certo, siamo un po' distanti da un'idea di Storia che si costruisce attraverso l'attenzione ai fenomeni sociali e collettivi invece che ai singoli individui. Tuttavia il libro è come una collana di racconti, da leggersi uno dietro l'altro. Questo, in certe occasioni, può bastare.
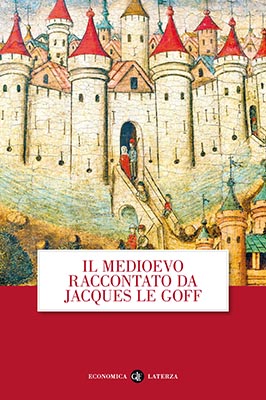
Un libro di molte qualità:
è utile, perché dà uno sguardo d'insieme al Medioevo, alle idee, alle vicende e alle caratteristiche di questo periodo
è piacevole, perché Le Goff lo sa raccontare, pur in una struttura a domanda-risposta, con una semplicità mai semplicistica
è agevole, perché ci fa capire molto senza dover scomodare troppe nozioni pregresse.
La storia si può, anzi si deve raccontare, come scrivo più avanti a proposito degli intenti divulgativi del prof. Barbero. Certo che Jacques Le Goff è uno dei più grandi esperti di Medioevo, e conosce bene le aule universitarie e le sale delle conferenze. Ma non ha paura nel mettersi a disposizione dei "piccoli" (in senso temporale e generale), e il risultato è eccellente.

Siamo tutti greci appare talvolta contraddittorio, come lo stesso autore dichiara alla fine del saggio: non lasciamoci intrappolare dal desiderio di vedere nei Greci antichi noi stessi e la nostra società, perché le differenze di duemilaquattrocento anni ci sono e si fanno sentire. Ma in realtà, il libro del prof. Zanetto ci convince di ben altro: che la Storia antica non è così distante; che Aristofane e i tragediografi greci avevano capito già tutto; che ai Greci antichi siamo debitori di molto.
Da leggere, assolutamente,
