A.S. 2017/18
Che si legge quest'anno? Si legge quel che si può durante diversi periodi di fermo forzato, ma senza alcuna forzatura. Le mie scelte non sono né coerenti in senso letterario né sempre utili in senso didattico. Il piacere di leggere è, e rimane, un modo di vivere un po' di più. Se non ci credete, provatelo.

Dopo aver visto il film in lingua originale ho ripreso in mano questo romanzo che lessi circa sette anni fa... con gran godimento, come tutti i romanzi di Jane Austen.
Ammetto: il film è ammiccante, piacevole e sicuramente di più facile lettura (con alcuni artifici anche discutibili, come il finale che si discosta dall'originale o il taglio di molte parti gotiche); ma le opere della Austen meritano di essere lette per se stesse e per l'ironia graziosa che le attraversa.
La scrittura ossessiva, spiraliforme, ricorsiva e a tratti ipnotica di Thomas Berhard non lascia mezze misure: o la sia ama o la si odia. E' impossibile restare indifferenti al continuo sobbollire delle medesime frasi, degli incisi che si ripropongono come realtà di altri, spesso riportata da interlocutori e quindi di terza mano.
Quest'opera è sicuramente più modesta per dimensione e tema narrativi - il camminare come procedere in una meditazione senza speranza, esasperata dal continuo del moto simultaneo di arti e mente, fino a diventare un tutt'uno parossistico che può condurre alla follia. Si ripropone comunque la polemica consueta, lucidissima, di Berhard contro le distonie accette dai più: l'autocompiacimento del bottegaio (di tessuti o di cultura, non importa), la limitatezza mentale dei medici (questa volta è la figura dello psichiatra a uscirne malconcia), la ricorrente monotonia della società contemporanea che premia coloro che sono privi di intelligenza - umiliando chi, con i suoi spunti creativi, ne denuncia l'ottusità di fondo.
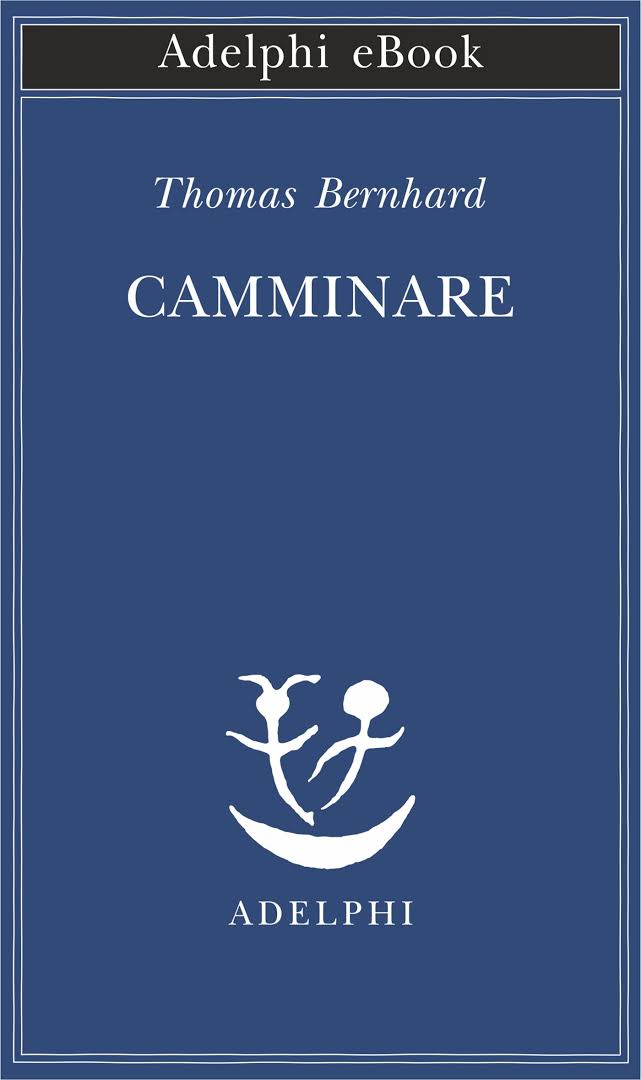
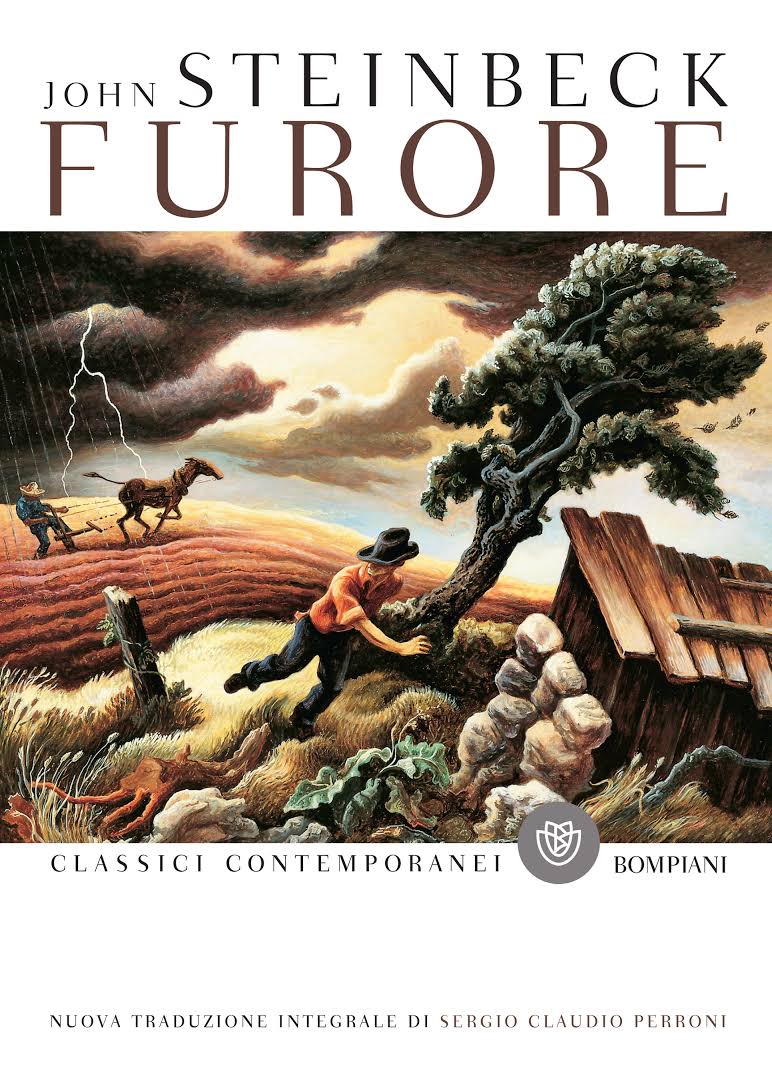
Sebbene questo libro sia considerato un classico, avevo doppiato il mezzo secolo senza averlo ancora letto. Mio marito ha provveduto alla lacuna, regalandomelo in occasione di un week end particolarmente piovoso, scegliendo l'edizione tradotta pochi anni fa a partire dal testo integrale e non quello censurato che per 70 anni ha risentito della censura fascista.
La sera della domenica il romanzo era terminato. Forse a qualcuno darà fastidio il tono profetico di chi vede nell'incessante progresso economico la perdita dell'umanità. Ma la vicenda della famiglia Joad è anche il canto epico di chi lotta caparbiamente per mostrare dove sta l'ingiustizia e dove la verità. E in questa testarda convinzione sta la bellezza di almeno metà della narrazione.
Un libro che ha avuto su di me effetti assai benefici: mi sono divertita, l'ho apprezzato nel suo bel stile diaristico, mi ha rincuorato e mi ha fatto venir voglia di andare a comprare qualche libro usato. Il che, per chi conosce la mia idiosincrasia igienista, ha quasi dell'incredibile. Nelle descrizioni ho riconosciuto un buon numero dei miei ex utenti e anche attuali studenti con relative famiglie. Sicuramente un titolo molto più intrigante e avvincente di quanto mi aspettassi. A parlare di libri si rischia sempre di cadere nella retorica, e di usare frasi del tipo "la lettura rende migliori", "leggere ti dona felicità"..., affermazioni che alla lunga si rivelano sbilenche e irrealistiche. L'autore invece dimostra, e senza alcuna intenzione di farlo, quanto leggere e circondarsi di libri renda la vita più lieve e più facile da accettare. E non è poco.


Storie di sfortunati famosi, per ribadire che la sfortuna esiste e colpisce alla cieca. Un volumetto interessante e godibile, con belle tavole che accompagnano la vicenda di ogni personaggio. L'ho letto durante alcune circostanze in cui pensavo che una nuvoletta nera mi stesse seguendo. La nuvoletta ha continuato a seguirmi, ma mi sono sentita meno sola.

Confesso: non avevo mai letto nulla di Elena Ferrante. Qualche anno fa avevo cercato di seguire il consiglio di mio nipote, che mi consigliava senza alcun tentennamento L'amica geniale della stessa autrice (o dello stesso autore?). Non riuscii ad andare oltre la decima pagina. Il proposito di riprovarci, con uno dei suoi romanzi più famosi, mi è stato dettato dalla polemica che sulla Ferrante si è aperta sulle pagine dell'Espresso tre settimane fa, e che da allora macina interventi a favore e contro la rappresentatività di questi titoli come punta di diamante della narrativa italiana, visto soprattutto il successo ottenuto all'estero e in particolar modo in America.
Beh, ora che l'ho letto lo posso dire: io sto con quelli che non capiscono che cosa Ferrante abbia di così speciale. Ma mi dedicherò, giudiziosamente, ad altre prove: con il dubbio, tuttavia, che il battage faccia molto più rumore di questa scrittura che ho avvertito monotona.
Mi piace la montagna, ma non credo che basti a spiegare perché ho letto il romanzo in una mattinata, tutto d'un fiato, come un'escursione che ti porta via via sempre più in alto.
L'ho letto con gusto, perché è bello, sentito, avvincente. L'ho letto con passione, perché l'amicizia tra Berio e Bruno è un sentimento forte, di quelli a cui ti puoi aggrappare quando perdi la fiducia in tutto il resto. L'ho letto con piacere, perché è ben scritto, di una scrittura pulita e senza leziosaggini.
Meritatissimo Premio Strega. E forse anche di più.

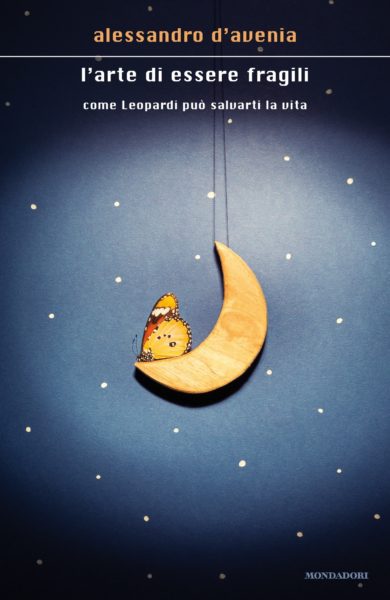
Prima premessa: chi volesse leggere questo libro troverà
pagine interessanti, anche se non del tutto originali, perché Leopardi è interessante e sorprendente, nella sua cristallina complessità.
Seconda premessa: chi volesse intendere questo saggio come una riflessione su
come far giungere la poesia e la poetica di Leopardi ai ragazzi, può
confrontarsi con alcune affermazioni di D'Avenia, e innestare tale contributo
sulla propria azione didattica, anche ex contrario.
Dopodichè, l'Arte di essere fragili è quasi interamente dedicato non a Leopardi, ma a quanto D'Avenia usi Leopardi per sé: operazione assolutamente plausibile, ma che ripetuta per 415 pagine appare stucchevole e noiosa. E' un bravo docente, va bene, ma chissà se le sue considerazioni sulla commossa fragilità del poeta di Recanati sarebbero valide in una combattiva scuola professionale del Giambellino anziché del prestigioso San Carlo. Gli studenti di D'Avenia sembrano tutti esemplarmente utili al suo discorso, non ce n'è uno fuori posto; ma fuori posto appare la retorica religiosa (a tratti marcatamente ciellina) sottesa a tutto il saggio, dove l'infinito di Leopardi riecheggia la ricerca dell'amore divino.
Un certo numero di lettori si innamorerà di quei passi dove D'Avenia insiste sulla necessità di andare oltre il programma scolastico, per promuovere la lettura dei classici al posto della frammentata trattazione scolastica delle indicazioni ministeriali; plausibile anche quel sentimento, ma si tratta di quanto dice e pratica una buona parte (diciamo il 30%, ma per difetto) dei docenti di lettere delle superiori. Di questi è meno facile innamorarsi perché parlano e agiscono nella concretezza imperfetta dell'azione quotidiana, e non possiedono l'appeal letterario di D'Avenia; per lo meno però, se parlano di Leopardi, parlano di quest'ultimo, e non di sé.
Un consiglio: potete evitare le 415 pagine di questo libro, ma non lasciatevi scappare il ritratto di Leopardi che ci ha lasciato Sebastiano Vassalli in Amore Lontano del 2005, un ritratto non idealizzato e più onesto per una conoscenza non ingessata del poeta dei Canti.

Libro che ha vinto il Pulitzer, che a molti è piaciuto, ma che forse si sarebbe giovato di almeno un terzo di pagine in meno. La struttura narrativa è quella usata da molti narratori americani: il racconto non è una storia che si srotola con i suoi adagio e i suoi presto, ma è una serie di fotografie che vengono accostate, e neanche sempre in sequenza ordinata. Tecnica legittima, che però a lungo andare stanca... soprattutto se non ci associ qualche guizzo narrativo (ne ho contati un paio in tutto il libro).
Quanto all'idea della protagonista /coprotagonista in una serie di episodi tutti ambientati nello stesso paese del Maine, mi sembra si tratti meramente di una trovata editoriale piuttosto che di un personaggio-collante: in molti racconti potresti modificare il nome e il personaggio di Olive e/o di suo marito con altri personaggi e il risultato non cambierebbe.
Infine, posso concordare che la Strout voglia descrivere un microcosmo/macrocosmo stanco, grigio, doloroso. Ma affogarlo nella collana monocorde di cartoline senza speranza getta il libro nella ripetitività. Scrittura femminile? Mah, non si avverte alcun accenno partecipe.. Insomma, siamo sicuri che questi narratori americani siano così grandi? Vedi il libro della Hornby qui sotto, è tutta un'altra melodia.
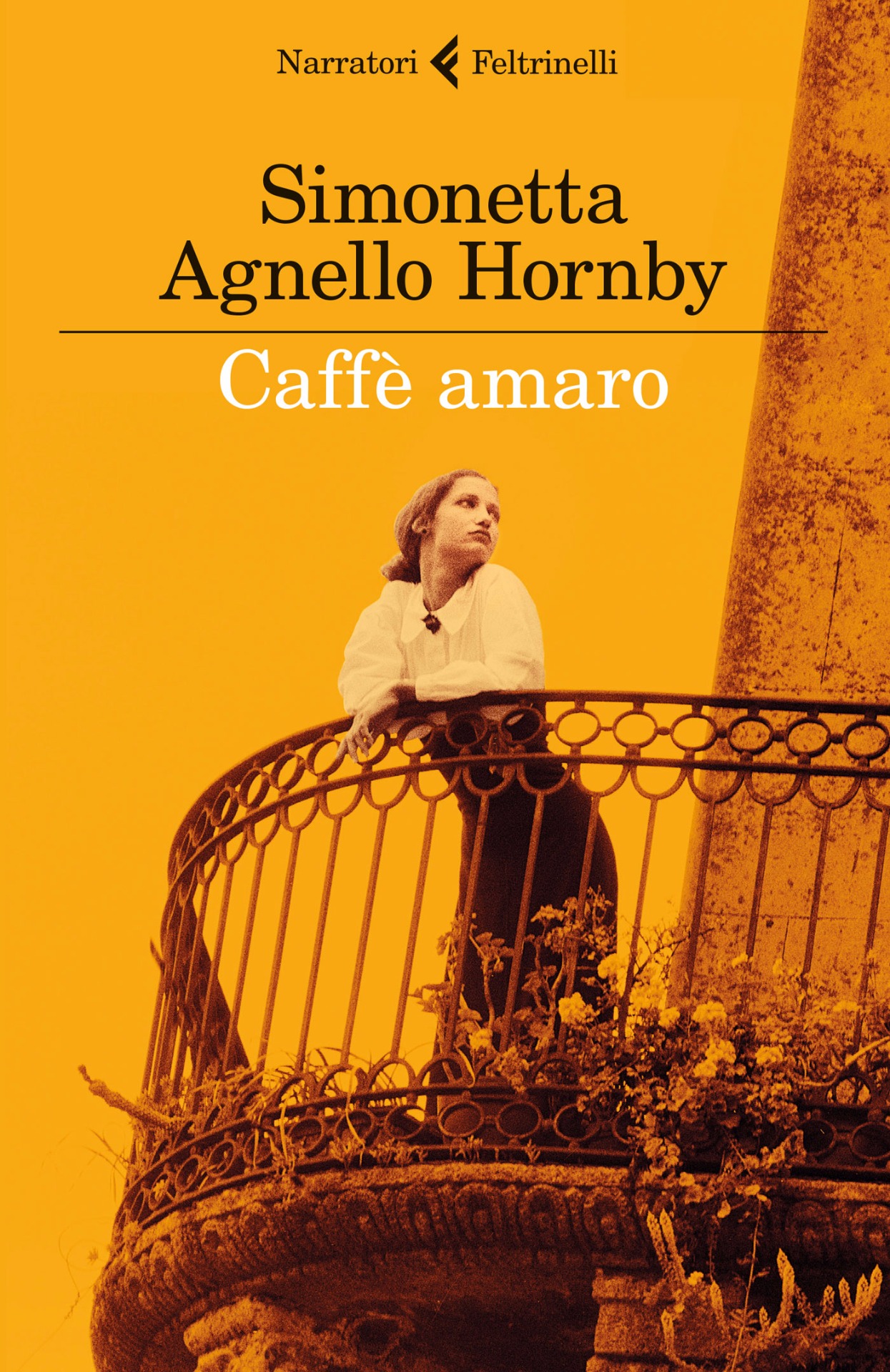
La vicenda è incentrata sulla vita di una donna siciliana che appare, ancora ai nostri occhi, fuori dal comune. Ma è il senso del racconto, la volontà di costruire una storia con i suoi respiri ampi o appena accennati, i primi e secondi piani, le sorprese e le conferme dei vari episodi: una storia dove l'autrice dimostra sapienza e passione narrativa.
Letto d'un fiato, nonostante le 400 pagine. Si sente che il lavoro di ricerca è stato lungo e dettagliato, ma se volete andare per le spicce nessuno se ne avrà a male. E' il raccontare che ha i suoi tempi lunghi, come le abluzioni profumate di Maria. Letteratura di intrattenimento? Forse, ma d'alto livello. E poi, che cos'è raccontare se non intrattenere; tenere legati, svolgere accadimenti e trattenere l'attenzione di chi ascolta (legge)?
Un esempio efficace di come la buona narrativa non abbia bisogno di effetti speciali, ma di cura e dedizione, presenti ad ogni pagina.
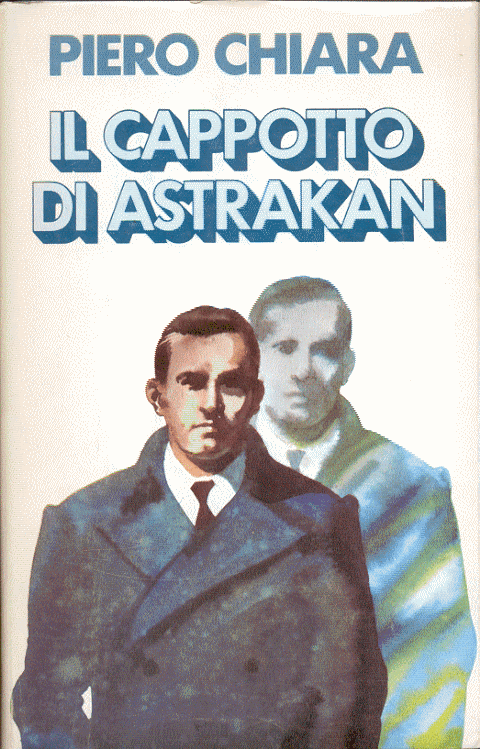
Romanzo modellato e costruito con eleganza. Inquietante nei suoi risvolti, ironico nelle osservazioni di fondo; cesellato nella prosa, godibile nella sua brevità. Generoso anche di elementi autobiografici, ma sempre con un occhio divertito... un novello casanova del Lago Maggiore a Parigi (inevitabile il riferimento all'autore di cui Chiara curò l'opera).
Ho letto che il film tratto dalla storia è ben poca cosa. A leggere in giro per il Web, Chiara è rimpianto da molti... L'ecclettismo di questa figura, che si diplomò perito meccanico all'Omar di Novara ed ebbe la laurea honoris causa, ne fece un conferenziere e uno scrittore di successo.

Visto che a ogni incontro con i miei lettori (poco più di venticinque, spero che don Lisander non se la prenda) ritorna il fantasma di questo scrittore, da oggi ho (ri)preso in mano le sue opere. Questa è senz'altro una delle più godibili anche se soffre di una certa zoppia finale, che forse i lettori più smaliziati avvertono più di altri. Peraltro, il romanzo breve in questione ha una pulizia stilistica e narrativa al cui confronto molti contemporanei contorti sembrano pivellini. Quando si legge si pensa: beh, che c'è di così difficile? Posso farlo anch'io! Ovviamente quando ci provate vi accorgete di ben altro...
Qui sta la grandezza di Piero Chiara ma probabilmente, ahimè, anche la sua debolezza.
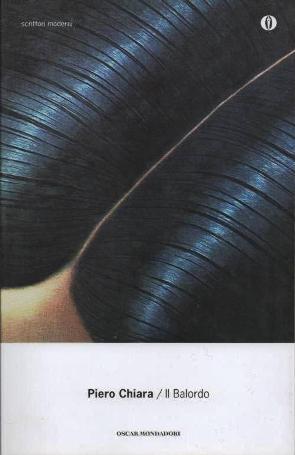
La vicenda è paradossale; il lettore sa che ciò che legge non è verosimile, ma l'autore gli permette di credere che possa essere vero. Ciò che spicca in questo romanzo è il gusto del raccontare, del dipanare una storia con mille rivoli che potrebbero farsi storie a sé stanti; e proprio come il protagonista sa suonare e dirigere un'orchestra al di là di ogni ragionevole convinzione, così il narrato si fa sinfonia, dove ogni parte, anche la più piccola, sembra avere assoluta ragione d'essere. I movimenti si susseguono, alcune parti si rincorrono, forse alla fine non le ricordate tutte; però le avete gustate tutte, senza eccezione.

Regalo in lingua originale da parte del marito, "così ti eserciti". Sì, ma il romanzo è troppo avvincente per aspettare: a pag. 35 ho ceduto. Ho preso l'e-book e l'ho divorato, così poi me lo rileggo con calma in lingua originale.
Finalmente un Premio Nobel alla letteratura di cui si condivide senso e valore. Non aspettatevi prosa magniloquente e descrizioni di ampio respiro. Qui l'indagine psicologica è tanto profonda quanto verticale, perché va dritta al punto: niente a che fare con lo stile robusto dei narratori russi, i dettagli minuziosi dei narratori vittoriani e gli incisi generosi di quelli francesi.
Eppure, il risultato non muta: grande letteratura.
Una mattina mi son svegliata e ho trovato l'sms di Daniela, la collega che ama i libri e l'inglese. Daniela mi rimandava alla lista del New York Times sui cento libri più belli del 2017.
All'interno del lungo elenco si ritrova il nome di Domenico Starnone: i suoi "Lacci" sono l'unico titolo italiano, recensito dal NYT con parole lusinghiere: "Ties" ------the leanest, most understated and emotionally powerful novel by Domenico Starnone
Beh, una presentazione così pregnante merita la fiducia del lettore, no?
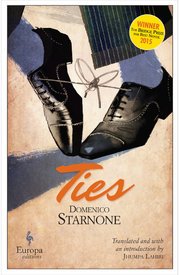
Che dire, alla fine? "Lacci"non è un bel romanzo, ma di sicuro è un buon romanzo, anche se nella vicenda non c'è nulla di buono. E' un buon romanzo perché è costruito con equilibrio e con forza. Viene ritratto il farsi e disfarsi dell'Amore, di cui la Famiglia è l'accessorio rotto e degradato, ma comunque inevitabile.
Se questo romanzo ha un difetto è, a parer mio, la scelta lessicale che talvolta si fa macchinosa, proprio come certi comunicati ideologici degli anni settanta. Ma per il resto il romanzo ha numerosi pregi: un taglio accattivante, l'incastrarsi delle voci, la visione delle cose secondo i punti di vista differenti che, al termine del libro, confermano come molti se ne potrebbero aggiungere, magari anche quello del lettore.
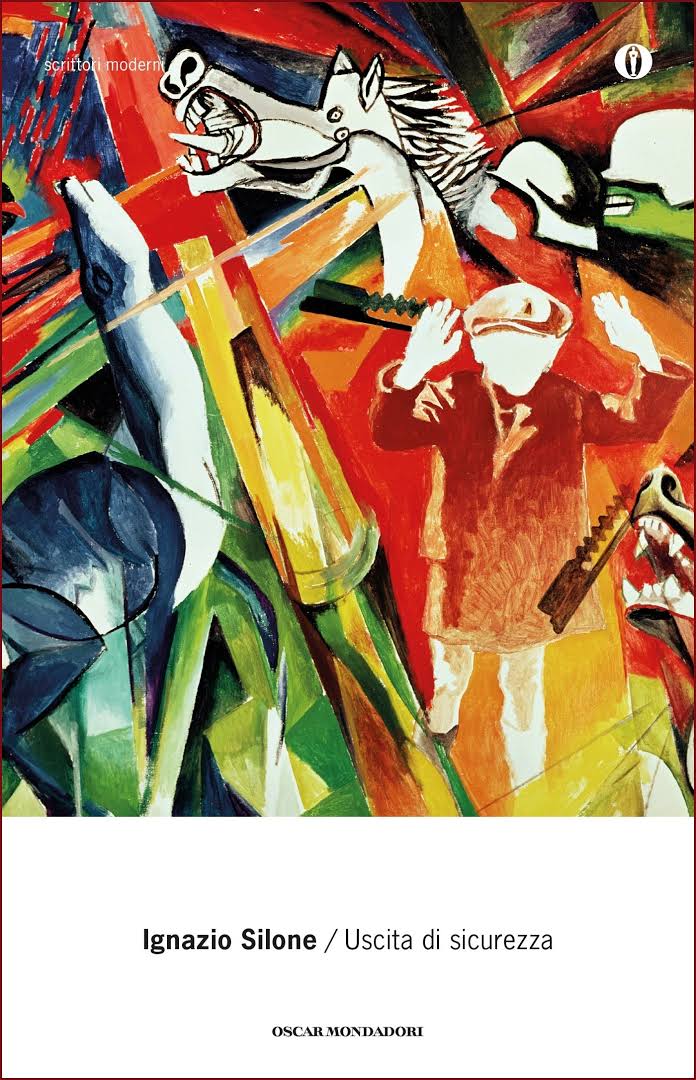
Questa raccolta di saggi uscì nel 1965 e fu il segno di una stagione in cui imperversavano le polemiche filo- e anticomuniste. Polemiche virulente, spiccatamente ideologiche, nettamente contrapposte l'una all'altra. Silone offre una serie di contributi legati al corso della sua vita: il fanciullo che si meraviglia con il padre dell'ingiustizia verso un uomo del paese; il giovane che vuole dare dignità ai braccianti abruzzesi; il militante comunista che non riesce ad apprezzare l'opacità burocratica sovietica; infine l'uomo di cultura che osserva l'insofferenza delle comunità nazionali poste al di là della cortina di ferro.
L'analisi di Silone è lucida e onesta, per nulla dedita al proselitismo anticomunista. E' innanzi tutto autoanalisi, indagine su se stesso e sulle ragioni che l'hanno portato prima ad aderire al socialismo e al comunismo, e poi ad uscire dal PCI. Silone offre di sé il ritratto di un uomo attratto dalla ricerca di un'etica privata e sociale che abbracci la verità e non ne abbia paura, nonostante l'alto prezzo da pagare. E' stupefacente, per le considerazioni espresse e la loro tuttora pregnante attualità, la disamina sulla corruttela italiana, che nello Stato prende piede perché tenacemente attaccata al privato familiare e personale.
Un classico riletto dopo tanti anni. La forza del romanzo è pari allo stupore che ci coglie quando ripensiamo alle condizioni in cui è nato: l'autore era in esilio, gravemente ammalato e senza nessuna certezza di poter tornare a vivere in Italia come libero cittadino. L'opera mostra delle incertezze nella scrittura, prima fra tutti i cambi di voce narrante che costringono di quando in quando il lettore a tornare sui suoi passi. Ma si tratta di dettagli che passano in secondo piano di fronte all'energia che trasuda da queste pagine e dall'intoccata onestà narrativa. Nulla è in più, nulla è in meno, niente suona artefatto, non c'è una riga che possa considerarsi superflua o sovraesposta.

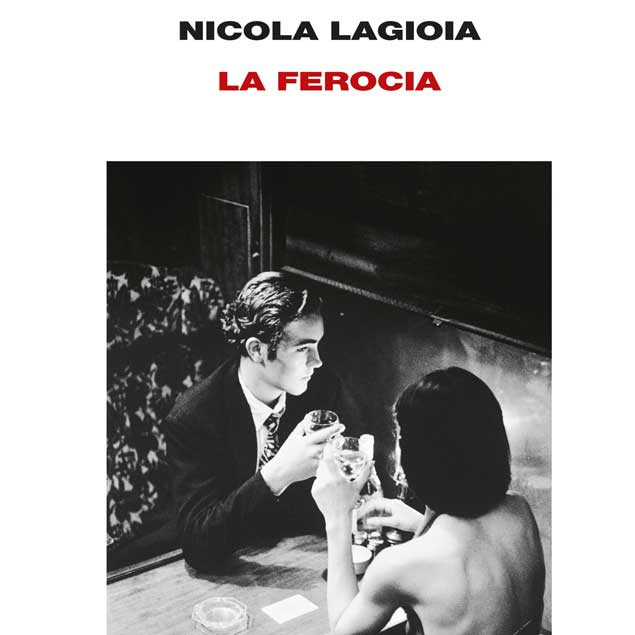
A mio parere un'occasione mancata. In questo libro lo sdegno per le vicende di corruzione e per il disamore che pervade i protagonisti va di pari passo con il voyeurismo e con uno stile che fa vacillare qualsiasi lettore, anche quello colto: barocchismi vacui e inconcludenti, periodare a tratti confuso, inserti incoerenti. Viene il sospetto tuttavia che non si possa dire nulla di negativo perché l'autore è consulente per Minimum Fax e penna onnipresente nel dibattito culturale italiano. Se ripenso all'ascesa e caduta di una famiglia, mi vengono in mente I Buddenbrook, Il velocifero, La casa degli spiriti... questo lavoro mi ricorda invece una grande luce al neon, forte e piatta, a tratti invadente e fastidiosa. Come se per parlare di perversioni e degrado si dovesse per forza alzare il volume al massimo: nell'ottenere l'effetto distorsione, si perdono profondità e interesse.



Una trilogia che a prima vista si potrebbe definire "il racconto delle piccole cose della provincia americana", ma così non è. La provincia di questa immaginaria cittadina del Colorado è infatti lo sfondo per inserire vicende di persone buone o cattive, non certo la descrizione fedele di una comunità americana. Mancano troppi dettagli perché la narrazione sia realistica, e del resto per Haruf (e credo anche per chi lo apprezza) la verisimiglianza sociologica passa in secondo piano. Quello che conta è l'intreccio delle vicende e dei sentimenti che ne scaturiscono: probabilmente troppo buoni, troppo edulcorati per chi ama le tinte forti e non il canto monodico di una pianura dove i venti sferzano gli uomini e asciugano le parole. Ne discende uno stile senza nessuna concessione all'introspezione psicologica: parlano i fatti, le azioni, il colore acceso di un viso o la goffaggine di un gesto.
Della trilogia il libro più bello è, a parer mio, Benedizione. Forse per il suo tono elegiaco, più attento ai sentimenti e aperto alla certezza che sì, alla fine è più facile avere fiducia nella bontà dei nostri simili, malgrado tutto. Forse perché mi è apparso come un potente controcanto a La morte di Ivan Ilic, nonostante il tono dimesso e grazie alla forza dei piccoli gesti. O forse perché alla storia dell'uomo che s'avvia all'appuntamento con la morte si affianca quella di un uomo che tiene vivo il suo ideale, anche se ciò significa morire agli occhi della comunità e della sua stessa famiglia.
Ringrazio Daniela, una mia collega, per avermi fatto conoscere questo autore e per aver condiviso con me la sua passione per la lettura: alcuni titoli di questa pagina vengono dagli scaffali di casa sua...

Un bel thriller. L'idea narrativa è ottima, l'intersecarsi continuo delle vicende dei protagonisti è ben condotto, il libro è accattivante... Ma il risultato complessivo delude, e alla fine pensi: tutto qui? Probabilmente non basta intrattenere il lettore, ma occorre dargli anche una chiave di lettura, che qui non c'è: spente le luci, il libro si chiude e si dimentica in fretta.

II filo rosso che conduce le piccole storielle di cui è protagonista Keret è la felicità. Felicità è accettare la tragedia quotidiana non con rassegnazione ma con ironia e autoironia, fino a ricordare inevitabilmente, per certi tratti, il Witz ebraico, messo in luce da Freud e definito "l'espressione dell'umanità che resiste all'orrore" (Claudio Magris). Ma al di là delle inevitabili connotazioni ebraiche presenti in questi raccontini (l'autore e la sua famiglia vivono in Israele, e di quando in quando si levano i ricordi dei nonni polacchi e dei famigliari sterminati dai nazisti) ciò che resta al lettore è il senso di leggerezza: perché la vita è talmente greve che non ha senso lamentarsene, neppure quando tuo figlio nasce il giorno di un attentato terroristico e a tuo padre viene scoperto un male incurabile. Anche qualora la cattiveria umana sembra più forte (la guerra, la maleducazione di un tassista, il pregiudizio di alcuni) il sorriso non sciocco ma consapevole, dunque ironico, mitiga i morsi del male e permette di vedere il mondo intorno a noi come un'occasione da cogliere, sempre e comunque. Persino quando la sorella ebrea ortodossa muore al mondo, Keret trova nel legame e nell'affetto qualcosa che, comunque, è un pochino di più del nulla. Pur senza scomodare la psicanalisi e Ferruccio Fölkel, la capacità di ridere di se stessi e di ciò che circonda è una qualità importante che si è persa e che andrebbe reimparata e reinsegnata soprattutto alle giovani generazioni, che invece spesso si gettano a capofitto nell'irrisione, e cioè nella distruzione, dell'altro e di se stessi.

Qualcuno ha scritto che Stoner è un capolavoro, e non sembra difficile condividere quest'asserzione. Il romanzo è il canto perfetto ed elegante dell'attenzione alle piccole cose, a un microcosmo che può diventare una voragine tragica o un radioso orizzonte, attraversando una strada di mezzo fatta di quotidianità e di routine. L'attenzione ai dettagli si declina nelle descrizioni attente senza mai essere sovraccariche. La prosa di Williams non è né austera né minimalista, bensì curata e limata con una sobrietà puntuale che, alla seconda lettura, lascia talvolta stupefatti. Il protagonista e le sue vicende sono rappresentati con una fine aderenza realistica e psicologica. La vita di Stoner, proprio per la sua apparente insignificanza, rivela una grande ricchezza di significati, disseminati in episodi narrativi di grande impatto narrativo.
Che cosa disturba dunque la lettura di questo libro che potrebbe essere un capolavoro e non lo è? L'amarezza che ci coglie man mano la lettura procede, e che alla fine lascia delusi. Un protagonista non deve per forza essere simpatico, ma la sua stessa deve essere giustificata e fors'anche interpretata. Qui invece abbiamo un uomo che ama la letteratura, e ne fa la sua ragione di vita e di lavoro, ma che dalla letteratura non ha imparato nulla. Non gli ha permesso di riconoscere l'amore, l'odio, il coraggio, la paura, e di farsene carico. La frequentazione dei testi poetici sembra non alterare l'analfabetismo sentimentale di Stoner che rimane a guardare la vita senza alcuna curiosità e senza la volontà di andare a fondo. Se sceglie, sceglie male; se reagisce, reagisce male; se cambia idea, se ne pente e ritorna sui suoi passi. All'interno del romanzo ci sono dei passi in cui si riflette sulla figura e il lavoro dell'insegnante, pregni di un'analisi sensibile, incisiva, sicuramente interessante, Tuttavia, alla luce di tutta la vicenda, la figura di Stoner appare più che mediocre, direi insulsa nel suo essere un uomo dedito a una catena di montaggio che la vita gli propina e dalla quale non si stacca.
E viene da invocare: perché il canto quinto dell'"Inferno" di Dante o quello della pazzia di Orlando dell'Ariosto, un sonetto del Petrarca, un carme di Catullo, il dialogo di Romeo e Giulietta (proprio in quell'anno Shakespeare moriva) non volarono ad aiutare un tal nefasto cretino a guardare dentro di sé, a capirsi, a capire? (Poiché nulla di sé e del mondo sa la generalità degli uomini, se la letteratura non glielo apprende.) - [Leonardo Sciascia, La strega e il capitano]
Stoner non ha appreso niente dalla letteratura. Sarà anche stato un bravo insegnante per la Columbia University, ma attraversa la vita e il romanzo senza lasciare a chi legge la voglia di andare più in là.

Continua, complice anche il tempo della convalescenza, la riscoperta delle opere di Silone che avevo letto tanti anni fa al liceo. Non posso aggiungere nient'altro a quanto già scritto più sopra, se non che l'ostracismo contemporaneo verso questo scrittore è tanto patetico quanto, ex contrario, prova di autentico valore letterario. Imperdibili le descrizioni di alcuni personaggi che appaiono attualissimi nonostante la vicenda sia ambientata nel primo dopoguerra : vedi il rampante don Franco, che usa il breviario come trampolino per progetti edilizi. Il tema del diritto che non è giustizia emerge prepotente, nella critica alla presunta razionalità dei codici che non sanno abbracciare la complessità delle vicende umane. A questo tema si affianca, potente e determinato, quello della forza dell'amore, che dà all'uomo la ragione d'esistere e di respirare - e tutto questo senza neppure una scena di sesso!
Chapeau.
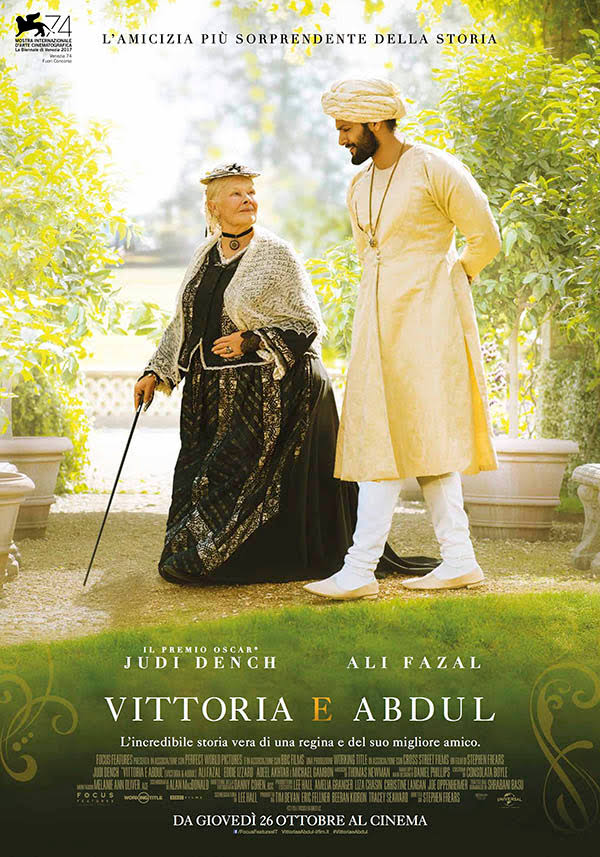
E' uno di quei libri che vengono inghiottiti dal film tratto dalla vicenda narrata. Tuttavia, per chi non si lascia scoraggiare dall'asimmetria mediatica, si leggono pagine costruite in autentico stile docunovel, con diversi riferimenti ai testi d'archivio, seppure generici. Per uno storico, troppo poco. Per chi storico non è, invece, la curiosità è appagata dai dettagli generosi e soprattutto dalla volontà di dipanare il racconto in modo lineare, senza alcun artificio narrativo.
Se sarete in grado di non perdervi attraverso la messe di nomi che l'apparato a inizio testo non riesce a domare, vi troverete tra le mani una lettura piacevole, costruita con onesta attenzione sia alla vicenda che al lettore. Attraverserete così gli ultimi tredici anni di regno della Regina Vittoria senza troppi echi della Storia che si intreccia a questa piccola storia... Da leggere nei pomeriggi di pioggia, la sera davanti al caminetto, insieme agli amici del gruppo di lettura.
Personalmente ne ho ricavato una grande antipatia per il Mushi Abdul Karim, bugiardo e presuntuoso, e ho rafforzato la convinzione che se l'Inghilterra è stata una grande monarchia, è perché funzionava perfettamente la sua burocrazia, lasciando ai sovrani le decisioni di contorno.
Ringrazio la mia collega Paola, che mi ha regalato non solo una visita ma anche l'occasione per avvicinarmi a una prova narrativa un po' diversa dai generi che di solito frequento.
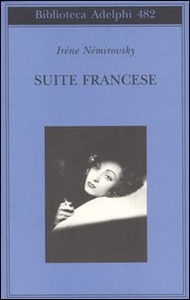
Capolavoro. L'ampiezza del respiro narrativo di Tolstoj a cui aggiungere una pervasiva finezza psicologica, peraltro intessuta di ironia. La Némirovsky descrive e analizza i sentimenti di una comunità con un'intelligenza equilibratissima. Alcuni passaggi dovrebbero essere citati nei manuali di sociologia e di storia, tanto sono perspicaci, tanto bene sanno leggere un tempo e una società... ma lo sono senza mai inclinarsi (non dico cadere) nella pedanteria. Come è la migliore letteratura, no?
Non fatevi ingannare dalla pellicola uscita qualche anno fa: come al solito, non rende giustizia alla semplice coralità dell'opera e alla sua tessitura a tratti impalpabile, a tratti potente.
Non posso aggiungere altro: se non lo leggerete, peggio per voi.

Intendiamoci: per parlare con accettabile contezza del libro dovrei leggere gli altri contributi che hanno tentato di affrontare la questione, ancora non risolta, dell'uccisione di Mussolini e della Petacci. Proprio a quella vicenda si rifece lo storico Renzo De Felice, forse lo studioso che più di ogni altro in Italia si dedicò all'analisi della biografia storica del Duce (8000 pagine!). Poco prima di morire De Felice fornì in Rosso e nero (1995) la sintetica anticipazione di quanto non riuscì a completare: «Nessuno ha mai avuto il coraggio di raccontare che cosa è veramente successo fra il 27 e il 28 aprile a Salò e a Giulino di Mezzegra. Tutto è rimasto oscuro, alla mercé delle più terribili dietrologie».
Prendo a prestito queste parole per commentare il titolo in questione. Interessante perché scritto da un uomo cui non bastò l'adesione alla RSI come combattente e al MSI come attivista e parlamentare, ma elevò a ragione di vita il denigrare, sempre e comunque, l'attività dei partigiani e di coloro che contrastarono la RSI.
Troppo poco perché un saggio, seppure ragionevolmente militante, non diventi stucchevole e a tratti ridicolo. Pisanò, per esempio, attribuisce indirettamente ai dissensi sulla morte di Mussolini una serie di morti tra i partigiani che invece vanno attribuite esclusivamente ai dissensi interni e alla vicenda dell'"oro di Dongo" (il "tesoro" di Mussolini di cui entrarono in possesso alcuni esponenti del PCI). Nulla di trascurabile da punto di vista storico e tantomeno giustificabile dal punto di vista morale, ovviamente; ma non si tratta di quella dicotomia buoni/cattivi invocata da Pisanò. La Resistenza è stata una narrazione eroica con alcuni episodi per nulla eroici, di cui avevano parlato Calvino e Fenoglio fin dall'immediato dopoguerra (autori non certo filomissini!). Inoltre Pisanò sottolinea più volte come il silenzio sulla verità venne imposto a testimoni diretti e indiretti con un clima di minaccia e intimidazione che sarebbe durato per almeno cinquantanni. Ma certo, dato che durante il Ventennio fascista e la RSI di minacce e intimidazioni non ce n'erano mai state (no, eh!), la gente non era in grado di affrontare tutto quel clima di terrore post repubblichino.. peccato che passati i cinquantanni la famosa consegna del silenzio è continuata, i notevolissimi dossier che avrebbero dovuto essere rivelati non sono mai saltati fuori, e l'unica testimone è rimasta una donna che si fa viva nel 1996, a settanta anni, con un racconto che non dice molto di più di quello che già molti sapevano: non era stato un semplice ufficiale partigiano a pensare di uccidere Mussolini e la Petacci. Fin troppo ovvio: un semplice ufficiale partigiano non sarebbe mai uscito vivo da una simile bravata. L'ordine arrivò sicuramente dal CNL, anche se non si sa con esattezza chi fu l'esecutore (davvero Longo?).
In alcuni passi poi Pisanò va oltre il ridicolo, quando per esempio scrive che con la strage di Piazza Fontana iniziarono gli anni di piombo e gli attentati e gli omicidi delle BR. Peccato che Piazza Fontana, considerata "la madre di tutte le stragi", non fu certo ideata dalle BR, e appartiene invece a quella linea stragista di matrice nera su cui si eserciterà la copertura e la deviazione delle indagini da parte di alcuni apparati dello Stato, circostanza che non possiamo invocare per gli atti criminosi delle BR.
Infine, il sig. Pisanò è riuscito a scrivere del furto dell'oro di Dongo in un modo talmente livoroso che non è riuscito a far brillare la verità come avrebbe dovuto. Per quelli interessati, consiglio di leggere l'articolo uscito sul quotidiano "Avvenire" lo scorso anno: https://www.avvenire.it/agora/pagine/dongo-
Quanto a una Claretta Petacci vittima dell'odio partigiano, consiglio di vedere il video con l'intervento di Mirella Serri, autrice del saggio "Un amore partigiano: Storia di Gianna e Neri" , edito da Longanesi nel 2014, ma anche la sobria ricostruzione dello storico comasco Giorgio Cavalleri, per nulla prono alla propaganda comunista: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/25-aprile-l-Oro-di-Dongo-e-la-storia-di-Gianna-e-Neri-5c7699e0-bf7e-434b-9a6b-067772d1b68e.html
Ringrazio Maria Rosaria che non solo mi ha passato un volume ormai per molti versi introvabile, ma che mi ha permesso di conversare ancora su un tema sempre recente, quello del fascismo e della sua caduta... forse solo apparente...

Uno dei libri più brutti in cui sia incappata negli ultimi trent'anni. L'idea è innanzitutto confusa, ma ancor più mal costruita, delineata in modo incerto e con parecchie asincronie che l'autrice non riesce a gestire. Alcuni passi sono di fattura narrativa talmente grossolana che riesce difficile immaginare un lavoro di editing editoriale.
Ringrazio chi mi ha passato il volume, perché mi ha dato la possibilità, una volta ancora, di toccare con mano quanto possa essere distante il mercato dalla buona narrativa. E come il fatto di "pubblicare per un editore importante" non significhi necessariamente avere scritto "un buon libro".



