letture dell'a.s. 2021-22

Quanto ho invidiato l'autore mentre leggevo questo libro!
Il volume è stato un regalo di mio marito, impietositosi dell'ennesimo stop impostomi dalle mie condizioni di salute. Ebbene, la scelta è stata davvero felice: nel percorrere insieme a Cognetti il diario della sua avventura in montagna, una sorta di mitigato Into the wild in chiave valdostana, ho visto e provato di nuovo le immagini della montagna che tengo nel cuore.
Ma questo diario è ben di più. E' un inno all'esistenza silenziosa e non ostentata della montagna che si fa pazienza e passione. E' un incontro con le emozioni che percorrono gli animi degli uomini, e che li rendono così forti e anche così fragili di fronte alla complessa semplicità della natura. E' un canto ispirato dalla bellezza della solitudine che si trasforma in volontà di ascolto e di amicizia.
La prosa di Cognetti, come sempre, non conosce spavalderie ma nemmeno timidezze. Un libro che si legge con l'affetto di chi può condividere l'avventura di un altro e farla sua.

Nel nostro tempo sono molte le ricorrenze della parola "narcisismo" e di tutto ciò che le è semanticamente connesso. Viviamo in un'epoca in cui il selfie e il detto "pubblico un post, dunque sono" sembrano aver sbaragliato ogni tentativo di ricondurre la nostra identità umana a rapporti meno autoreferenziali, più empatici, più costruiti sull'ascolto che sull'esibizione. Eppure, nonostante le marcate ostentazioni egocentriche, l'infelicità sembra aver riempito ogni anfratto delle persone, sole o in coppia, figli o genitori, giovani o anziani. In questo libro, il noto psicologo e terapista Vittorio Lingiardi scompone e racconta le dissonanze di personalità riconducibili ai meccanismi narcisistici di diversa portata, e lo fa primariamente per un pubblico generico, non certo formato da professionisti.
Lodevoli sono i numerosi
riferimenti ai miti classici e a quelli moderni, intendendo questi ultimi con
il cinema, di cui l'autore è un ottimo conoscitore. Di certo vince il confronto
con Recalcati sulla capacità di citare i miti antichi per narrare e indagare le
distonìe della psiche umana.
Ma per chi voglia accostarsi al volume con
autentico interesse occorrono, a mio parere, due premesse.
La prima, è che nell'architettura del volumetto (non è un trattato scientifico, ma si sviluppa per circa 150 pagine) c'è una parte dedicata a una descrizione più tecnica, che è comunque difficile da seguire per i non addetti ai lavori. Forse il lettore farà un po’ fatica a tenere a mente i termini legati alla fisiologia cerebrale, ma è una parentesi che può essere aperta o chiusa a proprio piacimento senza troppo penalizzare la comprensione globale del volume.
La seconda è molto più lunga, e mi devo scusare se qualcuno si sentirà offeso o forse qnche vilipeso. Ma in un’epoca in cui il ricorso alla psicoterapia sta diventando una sorta di passepartout per ogni esistenza e per ogni difficoltà, bisogna a mio parere accostarsi al contributo di Lingiardi senza dimenticare di considerare ogni visione psicoterapeutica per quello che è, ovvero una non-scienza,
necessariamente inesatta (del resto le stesse scienze sanno che le tesi postulate
possono essere superate) e soprattutto fondata su di un assioma ritenuto intoccabile: ovvero
che ogni aspetto ritenuto disfunzionale della persona vada
rintracciato nell'infanzia, con un lungo e tortuoso viaggio all'interno del
passato degli individui, alla ricerca di cause dovute a traumi infantili, mancati
o disturbati attaccamenti affettivi, incompleti sviluppi della personalità. Così
facendo, tuttavia, è come chiedere ad un infartuato di sessant’anni che cosa e soprattutto perché mangiasse in un certo modo a sei anni... una bella
perdita di tempo, non credete? Ma qualcuno obietterà: certo che se l'abitudine di mangiare
male nell’infanzia si è prolungata nel corso degli anni, il nostro sessantenne avrà le arterie sature di colesterolo. Però allora non sarebbe meglio concordare una
dieta e uno stile di vita più sano per il nostro paziente? Che senso ha ritornare su di un
passato irrimediabile e chiedergli "perché a 6 anni mangiavi i
ciccioli d'oca?, cercando le ragioni di una scelta compiuta tanti anni prima?
Ecco la ragione, almeno a parer mio (ma so di essere in buona compagnia) per cui non ha senso insistere sul "perché esiste il problema" e
cercarne le origini remote nel trascorso infantile. Va poi tenuto conto che non abbiamo una
certezza infallibile sul modello di ricerca, visto l'elevato numero di approcci
teorici, anche spesso contradditori, di cui lo stesso Lingiardi qui dà conto a riguardo
del narcisismo, ma che si possono comunque richiamare quando si affrontano altri disturbi della psiche.
A tale proposito voglio soffermarmi su di un riferimento che mi sta particolarmente a cuore, perchè a mio avviso rappresenta emblematicamante l’intrinseca fallibilità (e quindi inutilità) di molti interventi psicoterapeutici.
Qualche decennio fa si credeva che l'autismo fosse generato dal comportamento della madre nei confronti del figlio, e che quindi le radici dei disturbi autistici affondassero all’interno del rapporto tra i due. Si pensi che nel 1943 Leo Kanner sviluppò le prime ipotesi eziologiche dell'autismo infantile basate prevalentemente su considerazioni di natura psicologica e sociale. Seguì nel 1956 Szurek che coniò il termine «madri frigorifero» riferendosi a madri con uno stile relazionale improntato ad indifferenza, distacco, insensibilità, rigidità, incapacità di comunicare in maniera aperta e sincera, di sorridere e giocare con il proprio bambino. In accordo a tale ipotesi, questi genitori, a causa delle proprie caratteristiche personali, non sono in grado di rapportarsi alla realtà del figlio che diviene inconsapevolmente il bersaglio su cui proiettare i conflitti, bisogni, desideri. Circa dieci anni dopo fu pubblicato il celebre contributo dello psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim, che nella sua opera La Fortezza Vuota (1967), ratifica il concetto di «madri frigorifero», Bettelheim afferma: «Credo che la causa iniziale del ritiro autistico sia l'interpretazione corretta da parte del bambino dell'attitudine negativa, con la quale gli si accostano le figure più significative del suo ambiente». Secondo lo psicoanalista, le «madri frigorifero», troppo fredde e insensibili ai bisogni del bambino, generavano nei bambini l'idea che non avrebbero potuto influenzare in alcun modo il mondo circostante, inducendoli a ritirarsi in una sorta di fortezza vuota. In breve il trattato divenne un best-seller e l'ipotesi di Bettelheim ebbe una ripercussione mondiale, con forti ricadute nelle pratiche terapeutiche adottate. Infatti, Bettelheim, direttore della Orthogenic School di Chicago ribadisce la necessità di allontanare completamente il bambino autistico dall'ambiente familiare per inserirlo in un ambito terapeutico che promuova la sua crescita. In tal modo la famiglia viene colpevolizzata ed esclusa dalla vita e dalla terapia del bambino. (il testo in corsivo è tratto da: In difesa delle madri dei bambini con autismo - La Stampa; ultima visita 4 marzo 2022.)
Agli inizi degli anni '80 venne tuttavia dimostrato senza tema di smentita che l'autismo è dovuto alle anomalie di sviluppo del cervello e che ha basi genetiche. insomma: quarant’anni di colpevolizzazione delle madri (e anche dei padri) spazzati via da una ricerca scientifica. Ma quanti guasti quelle teorie psicologiche hanno inferto in molte famiglie (altro che curare)! Se avete voglia, andatevi a leggere il breve ma intenso contributo di una mamma con un figlio affetto da disturbi dello spettro autistico, così vi rivelerà anche che fine ha fatto Bruno Bettelheim: https://sondra3.blogspot.com/2018/08/il-13-marzo-del-1990-bruno-bettelheim.html
Pensare che un disturbo d'ansia o di depressione o di personalità narcisista, tanto per rimanere in tema, possa venire curato solo con un approccio eziologico che risalga all'infanzia e che richieda un prolungato e faticoso numero di sedute, protratte nel corso degli anni, fa ritenere che molti psicologi e psicoterapeuti (molti: non tutti) soffrano di un complesso di onnipotenza e si prendano così tanto sul serio da non poter scorgere l'imperfezione di fondo su cui basano le loro certezze, tetragone a ogni obiezione di tipo teorico e metodico.
Per il lavoro che ho svolto e per quello che ora svolgo ho avuto a che fare con un certo numero di psicoterapeuti, che invariabilmente chiedevano dai dodici ai trentasei mesi di sedute settimanali per curare disturbi d’ansia, di depressione, di disordini alimentari... e sulla mia perplessità per la lunghezza e il costo della cura (oltre che sull’impossibilità di assegnare un’oggettiva percentuale di successo) mi ribadivano che la psicoterapia è una scienza inesatta poiché le sedute non sono esperimenti, ma semmai esperienze. Qualcuno ribadiva l’imprescindibilità di un percorso così lungo, aggiungendo con orgoglio che si trattava di svolgere un lavoro bellissimo ma come tale faticosissimo, anche per il paziente.
Sul fatto che sia bellissimo non ho nulla da obiettare,
proprio come io penso che insegnare sia il mestiere più bello del mondo. Da qui
però a pensare che un docente abbia tra le mani solo verità inoppugnabili ce ne
corre. Traete voi le conclusioni.
Quindi leggiamo pure questo contributo, chiaro nella sua prosa, piacevole per i numerosi riferimenti culturali, e sicuramente stimolante per una riflessione su di un vizio che può, a quantità responsabili, essere perfino una virtù. Ma teniamolo sul comodino come potremmo tenere un saggio sui movimenti di Borsa: argomento, quest’ultimo, dove la serietà dell’argomento (e chi mai potrebbe negare l’importanza di guadagnare nella finanza?) va di pari passo con l’irrazionalità che pervade le scelte degli investimenti, anche quelli più accorti.
Avere "qualcuno da amare" è la cosa più importante della vostra vita? Credete costantemente in Mr Right, e stare con lui vi garantirebbe che non vi sentireste più depresse o sole? Siete annoiate dai "bravi ragazzi" che sono aperti, onesti e affidabili? Se essere innamorati significa soffrire, questo libro è stato scritto per voi.

Robin Norwood, celebre terapista di coppia, descrive l'amore "eccessivo" come un modello di pensieri e comportamenti, che alcune donne sviluppano come risposta ai problemi dell'infanzia. Molte donne si trovano ripetutamente attratte da relazioni infelici e distruttive con gli uomini. La Norwood scrisse questo libro dopo essere lei stata una "donna che amava troppo", non limitandosi a evidenziare quanto possano creare dipendenza queste relazioni malsane, ma fornendo anche un programma molto specifico per la guarigione dalla malattia.
Ho ripreso in mano questo volume solo per cercare un passo specifico, ma mi sono ritrovata a rileggerlo tutto (tempo di riletture, questa convalescenza!). Credo che l'opera dovrebbe essere letta da chiunque, donna o uomo, intenda affrontare nel modo il più possibile sereno le proprie relazioni sentimentali, e voglia rafforzare il rispetto per sé e per il proprio partner.
Da qui ad approvare l'ormai diffusa tendenza ad affrontare ogni difficoltà con il ricorso alla psicoterapia, dimenticando che in in molti casi qualcuno vicino può essere in grado di aiutarvi (lo afferma la stessa Norwood nel lontano 1985!) e si debba sempre e comunque ricorrere, per ogni piccolo problema, a un consulente esterno,,, Una tendenza che purtroppo si impone nella scuola ogni giorno che passa. Vedi a proposito la riflessione sul volume di Lingiardi.

Questa è una rilettura di una rilettura di una... eh sì, ho scoperto il fantastico mondo di James Herriot quando avevo dodici anni: me lo regalò mia sorella su consiglio dell'ex compagno di liceo Marco Varvello, proprio quello che si collega da Londra durante il TG.
È stata una scoperta che mi ha accompagnato tutta la vita, senza un briciolo di noia e sempre con gran gioia: nessuna esagerazione, è proprio gioia il sentimento che provo nel leggere le vicende di un microcosmo nello Yorkshire che può essere più vario ed entusiasmante di un giro intorno al mondo.

Si tratta di romanzi che non vogliono insegnare nulla, nemmeno l'amore per gli animali, e quindi, senza alcun intento didascalico, veicolano messaggi forti e rasserenanti: che gli animali possono essere compagni preziosi degli uomini; che la passione per il proprio lavoro è fondamentale; che l'amore e l'amicizia sono due sentimenti da coltivare con animo pieno di rispetto ma anche di levità, per non prendersi mai troppo sul serio e poter vivere così una vita piena e felice.
Pur amando molto i gatti, non ho scelto questo libro per trastullarmi nelle avventure feline di Benny, il primo gatto adottato da Jackson Galaxy. Ciò che è interessante di questo volume è la storia del cat-councelor attraverso la narrazione delle sue dipendenze: marjuana e altre droghe, sciroppo per la tosse, alcol, ansiolitici.. e alla fine, quando finalmente pensava di essere pulito, dipendenza da cibo, fino a ingrassare talmente a dismisura da essere costretto a sottoporsi a un intervento di by-pass gastrico.
Dunque la pet-therapy non ha funzionato con l'autore, ma questa rimarrebbe un'affermazione sarcastica e nulla più se non andassimo oltre e per vedere, in quel percorso raccontato con molta lucidità, la volontà di essere onesti e ottimisti nello stesso tempo: come a dirci che si può fare qualcosa di buono anche se si è nei problemi fino al collo, e che liberarsi dai propri demoni è difficile ma è indispensabile per vivere sul serio. Più o meno felici, questo non ha importanza: il racconto è un esplicito sforzo autobiografico di mettersi a nudo per guarire, e mostrare che per aiutare gli altri occorre, innanzitutto, avere consapevolezza dei propri limiti.

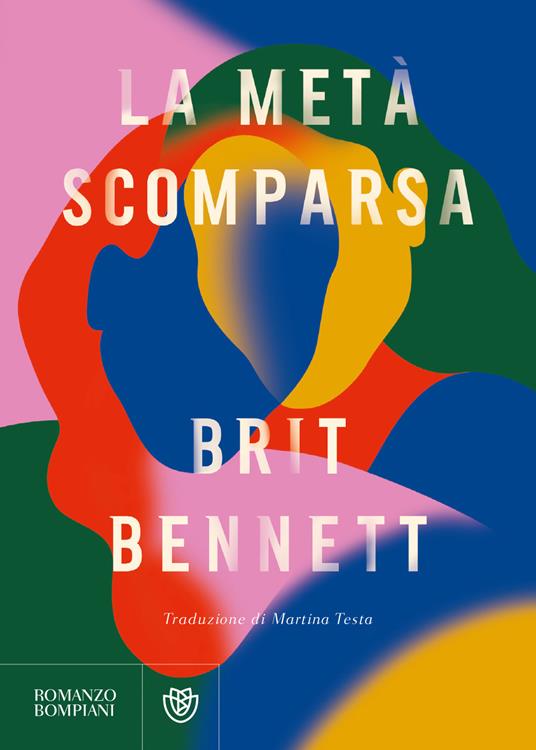
Quando degli ex-alunni mi regalano un libro sono sempre contenta, perché il seminato ha messo radici e foglie: non si regalano libri quando non si ama la lettura, è una verità che ho appreso da tempo senza possibilità di errore.
Questo poi è uno dei titoli che io non avrei mai scelto per conto mio, e questa evenienza mi ha reso doppiamente felice: è un buon romanzo, giocato sulla suspence e sull'introspezione dei sentimenti, come due flussi di narrazione che si intreccino e si biforchino ad ogni capitolo.
Con tutta probabilità questo romanzo non raggiungerà le letterature dei prossimi anni, ma rimane un esempio di come si possa scrivere della buona narrativa senza dover ricorrere a personaggi improbabili, eventi inverosimili e vicende sgangherate.

Un altro capolavoro della letteratura mondiale, uscito a circa trent'anni dalla morte dell'autore, quando le grinfie della censura sovietica lasciarono che la moglie di Bulgakov pubblicasse il romanzo, seppure con non pochi tagli. Stalin era morto da tempo e in tutto il mondo si era appreso come dato di fatto che la libertà del comunismo bolscevico consistesse in una fraudolenta illusione,
Uno dei classici della letteratura, ricco di colpi di scena, sequenze ricche di sapienza narrativa, pennellate parodiche stese senza alcuna grevità.. eppure, chiedo venia, non lo rileggerei. Perché? A mio parere rimane un classico ma sopravvalutato, e ingannatore nel titolo. Di amore se ne vede ben poco, nonostante Alessandro Barbero e altri commentatori si sprofondino a cantare le lodi dei colloqui struggenti tra i due amanti, ciò che dovrebbe caratterizzare quest'opera.. ma non è che si sono confusi con Il dottor Zivago??

Come l'altro memoriale-capolavoro sulla I guerra mondiale (Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu) in queste pagine si incontra la stupidità e la protervia degli uomini, unita alla vulnerabilità che fa di ogni soldato un soffio pronto ad andarsene per le ragioni più sciocche e inconsistenti. Cognac e alcol la benzina per aggredire; il dolore come sfondo comune. L'incomprensibile ragione della guerra diventa domanda senza risposta.
Quando tornerò in classe, darò entrambi i volumi da leggere, uno a una parte degli alunni, l'altro ai restanti, per un interessante confronto su analogie e differenze tra i due romanzi.
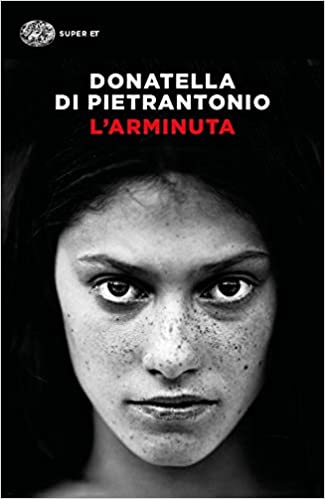
A chi è malato o si regalano biscotti (che poi regolarmente non si possono mangiare) o libri.
Questo romanzo mi è arrivato come un dono, e mi è piaciuto per l'intreccio pennellato con autenticità e una certa piacevole ruvidezza, come una tempera di fine Ottocento.
Tutta la vicenda è raccontata in prima persona, espediente che avrebbe potuto risultare alla lunga indigesto. Nulla di tutto questo invece, forse proprio perché l'autrice ha saputo calibrare bene i tempi e le sequenze narrative e descrittive, tenendo le proporzioni e non cercando l'effetto fine a se stesso.
Da qui a farne un libro indispensabile ce ne corre. Elsa Morante è ancora lontana. Ma è un romanzo che si può leggere e tenere in libreria.

Vicenda interessante (ve la vedete una piccola torpediniera sul Lago Maggiore?) e raccontata con l'intelligente scelta (di ascendenza manzoniana) di intrecciare il vero storico e il vero poetico.
Qualche piccola slabbratura di incongruenza temporale nell'intreccio non nuoce a tutto il resto. La lettura è gradevole e lascia aperte tante porte, come quelle del misterioso relitto mai ritrovato.

Quando parliamo di "letteratura onesta"? Quando la forma non prevale sul contenuto ma ne diventa complemento inscindibile. Quando l'autocompiacimento non strangola la linea di dialogo con il lettore. Quando il personaggio che scrive non prevale sui personaggi della vicenda.
Tutto ciò è lontano, anzi assente, dall'introduzione all'opera omnia di don Lorenzo Milani, introduzione scritta dal prof. Alberto Melloni, che di quell'opera ha diretto l'edizione nazionale. È conseguenza che io reputi "disonesto" quel contributo, attirando su di me non solo l'accusa di diffamare il lavoro e la persona dell'emerito professore, ma anche quella (apparentemente giustificata) di ignoranza, saccenteria e presunzione.
Sull'ignoranza posso chinare il capo, sulla presunzione e saccenteria no.
La disonestà di quella introduzione sta infatti proprio nella דבר- dabar, cioè la parola che si fa evento, fatto, cosa. E di fronte a quelle pagine che prova il lettore? Smarrimento se non irritazione. Davanti all'edizione di un autore, in questo caso μ (scelta peraltro intelligente e ispirata quella di scegliere la lettera greca a mo' di formula per indicare il priore di Barbiana), il critico non dovrebbe fare ombra, ma semmai dare luce, chiarire, finanche spiegare all'autore stesso ciò di cui quest'ultimo è solo parzialmente consapevole, immerso com'è nel processo di creazione. Il prof. Melloni invece si comporta come un testimone di nozze che toglie visibilità alla sposa, mettendosi davanti al momento della fotografia e rubandole la parola. La parola, sempre quella. Ve lo vedete don Milani che legge le pagine dell'introduzione? Io credo che non le avrebbe condivise, ma non per i contenuti, bensì proprio per lo stile.
Certo, si obietterà che di fronte alla scrittura denudata e incandescente di μ non necessariamente l'esegeta e il critico debbano similmente denudarsi: non è la mimesi a rendere efficace e convincente il lavoro critico. Tuttavia, se quest'ultimo si pone accanto alla figura e scrittura di μ apprezzandone l'estraneità dallo spiritualismo autoappagato, l'opzione stilistica lucida e consapevole, la scelta dell'asciuttezza e dello scorciamento, occorre andare anche più in là utilizzando le stesse parole fattuali (dabar!) del prof. Melloni.
Nell'introduzione leggiamo che μ esprime "una severa sorveglianza rispetto alle ridondanze dannunziane" e scarsa riverenza per "l'intellettualismo idealista e post idealista da cui venivano i suoi maestri", in una "lotta contro il nemico intellettualistico o estetizzante" in cui bisogna "togliere", come faceva Michelangelo col marmo, perché si ottenga "una parola scolpita, ostica al borghese, perché purificata di tutti quei trucchi e marchingegni intellettuali che non sono il segno di una profondità ma solo la squallida esibizione di una prepotenza di classe".
Esibizione e prepotenza; sono le parole (ci risiamo!) scritte dal prof. Melloni, che però proprio le merita per la sua introduzione. In quest'ultima i concetti sono rivestiti da scelte lessicali e sintattiche ostentate in una sorta di autocompiacimento stilistico che non solo vuole l'applauso e la lode, ma se li fa da sé, disprezzando tutto ciò che di pop o conformista (a suo parere) è da μ derivato: mostrando, il prof. Melloni, di essere diverso, di essere altro e superiore, citando (in modo del tutto gratuito, senza alcuna vera giustificazione di contenuto e di ragionamento) Cy Tombly, Ivan Illich, Yves Congar, e organizzando la sintassi in un rincorrersi di periodi barocchi che la Scuola di Barbiana non avrebbe apprezzato e che i lettori, almeno quelli che leggono don Milani dall'età di 12 anni come la sottoscritta, trovano inutilmente complicata e fuori contesto. Ho scritto complicata e non complessa, rifuggendo io stesso da quella approssimazione contro cui ci mise in guardia, molti anni fa, Italo Calvino, ricorrendo, guarda caso, proprio alla figura del diavolo.
Quindi, ritornando all'aggettivo che tanti problemi può crearmi, penso e voglio scrivere che l'autenticità e la profondità del contributo del prof. Melloni non si recupera nella ricercatezza lessicale, nell'affettazione della prosa e nella tortuosità concettuale. Bisognerebbe riscrivere quell'introduzione: ma proprio per il valore della dabar non si può fare, perché diventerebbe altro.
Il mio invito, umile ma determinato, è di leggere prima la prosa di μ (Esperienze Pastorali e qualche lettera lunga), e solo dopo affrontare il contributo introduttivo di Melloni: fate voi se a mo' di impietoso confronto o interessante paragone.