A.S. 2020/21
Quest’anno arrivo a scrivere delle mie letture un po' in ritardo, perché durante gran parte del tempo dirigo l’interesse verso articoli di giornale ed elzeviri, più consoni a darci lo spirito di questi tempi tribolati. Ma è arrivato il tempo della riscossa: ecco le mie letture, rigorosamente in ordine cronologico (la prima che incontrate è quella più vicina alla data odierna)
Opera di una docente di letteratura italiana con esperienza anche se non sugli scudi accademici, di agevole lettura per volontà della stessa autrice che ha voluto pubblicare un testo dai tratti romanzeschi e quasi di feuilleton, ma pour cause: in primo luogo, per farne un volume da leggere sotto l'ombrellone, magari commentando alcuni particolari un po' piccanti; in secondo luogo perché il ritratto di Claretta diviene il ritratto del fascismo degli anni Trenta e Quaranta, ovvero un cabaret tragicomico.
Il volume è ricco di particolari che consolidano la conoscenza della disastrosa dittatura che nessuno potrà rimpiangere se solo leggesse metà del libro. L'unico difetto di questo titolo sta proprio nel suo pregio, ovvero non essere solo il ritratto di Clara Petacci, ma anche della sua famelica famiglia, un vero esempio di virtù all'italiana di quegli anni; e ancora della corruzione che permeava lo Stato fascista, nel sottobosco di favori e intrighi dei corridoi governativi; e infine della tragica baldanza nazista che fece dell'occupazione in Italia l'epilogo di un'avventura totalitaria che aggiunse dolore e cieca violenza a dolore e cieca violenza, di cui Claretta si sentiva, nella sua ostentata superiorità, perfetta interprete, falsamente ignara tra sete e damascati.


Grandi poeti, non c'è che dire. Però furbe soluzioni editoriali che con il pretesto di consegnare un testo da far leggere ai ragazzi fanno delle scelte non sempre condivisibili. Da apprezzare però la traduzione dei testi di Shakespeare, attenta e ben curata dal punto di vista stilistico.

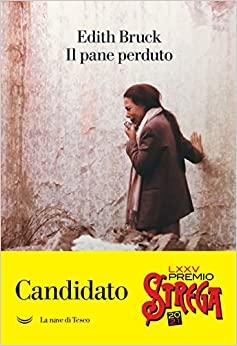
Perchè si legga un libro invece di un altro è circostanza legata anche agli accidenti della quotidianità. Il mio accidente è stata una notizia di cronaca che riportava la visita di Papa Francesco a casa di Edith Bruck: il massimo esponente della Cristianità nella dimora di una scrittrice ebrea che sessantacinque anni fa scelse l’Italia e la lingua del sì per la sua vita di donna e si scrittrice.
Non conoscevo Edith Bruck, chiedo perdono e mi riprometto di riparare. Questo libro è breve ma intenso, e dà luce all’emozione di una vita che non vuole smarrirsi, nonostante tutto, nonostante il Male: colora di allegria lo sbarco a Napoli, si nutre di incoscienza nella scelta di fare la ballerina, custodisce con fedeltà il ricordo senza che questo la faccia prigioniera. Ardente e limpido il brevissimo passo in cui narra la nascita dell’amore per l’uomo che resterà accanto a lei per sessant’anni; commovente la lettera a Dio, apprezzata anche da Papa Francesco.
In poche pagine ho ritrovato tutto: la stupidità della dittatura, la perfidia del pregiudizio, la Storia e la Shoah, la bellezza dell’amore, il pudore di un ricordo che non si trasforma in odio, Come potevo non assegnare questo libro ai miei alunni?


Ho letto l’opera di Antonia Pozzi sette anni fa e per puro caso. Lo stupore della scoperta si è fatto a poco a poco consapevolezza e ammirazione. Questi sono i libricini che ho scelto per i miei alunni, riprendendo in mano alcune delle lettere e delle liriche della giovane poetessa. Giovane quanto stupendamente capace di andare nel profondo delle emozioni, dell’amore, della vita.
L’equivoco è già nel titolo, che dovrebbe leggersi nel modo seguente: “Il comunismo spiegato secondo un gruppo comunista militante che rilegge Marx, Engels e Lenin”. I ragazzi, soprattutto di primo pelo, non ci capirebbero granchè: decifrare Lenin non è in effetti cosa da tutti, e con tutta sincerità non è facile seguire il discorso di un ragionamento che a tratti diventa soliloquio con un’articolazione lessicale e logica tutta a sè.
Peccato per l’occasione persa, perchè si smarriscono le cose buone di Marx quando si sostiene che nei Paesi dell’Est Europa non c’era il pluralismo politico al fine di contrastare i partiti reazionari. Nessuna spiegazione sulla caduta dei regimi totalitari, sulla necessità di ripensare le idee violente del rovesciamento sociale, e nemmeno sul bisogno di rivedere le concezioni datate, per alcuni aspetti, di Lenin e dello stesso Marx (che aveva davanti a sè un ceto medio ben diverso da quello attuale; e che non vide l’involuzione della Rivoluzione russa).

Peccato perchè il marxismo resta, su molti decisivi aspetti, un’ideologia profetica di cui ci sarebb davvero bisogno, a partire dal discorso sul profitto: è possibile considerare la crescita del profitto un disvalore anzichè uno stato di buona salute della società? È auspicabile che i lavoratori salariati vedano nel consumismo un pericolo e non un arricchimento?
La derisione dei socialismi utopici è storia, ma il fallimento dell’esperimento sovietico e cinese, con i mostri autarchici che hanno creato, non deve essere preso in considerazione?
Alla base del materialismo storico, al quale si rifanno inevutabilmente gli autori, non ci dovrebbe essere proprio l'analisi dei fattori storici?
Quante volte ho letto il romanzo di Giuseppe Tomasi da Lampedusa? Dieci? Dodici?
Molte, e tutte le volte è come se fosse la prima.
Questo ne fa un libro che è più di un classico. Non leggerlo equivale a tralasciare un'occasione preziosa.
Impossibile scrivere altro, guasterebbe. Leggetelo, poi ne parliamo.
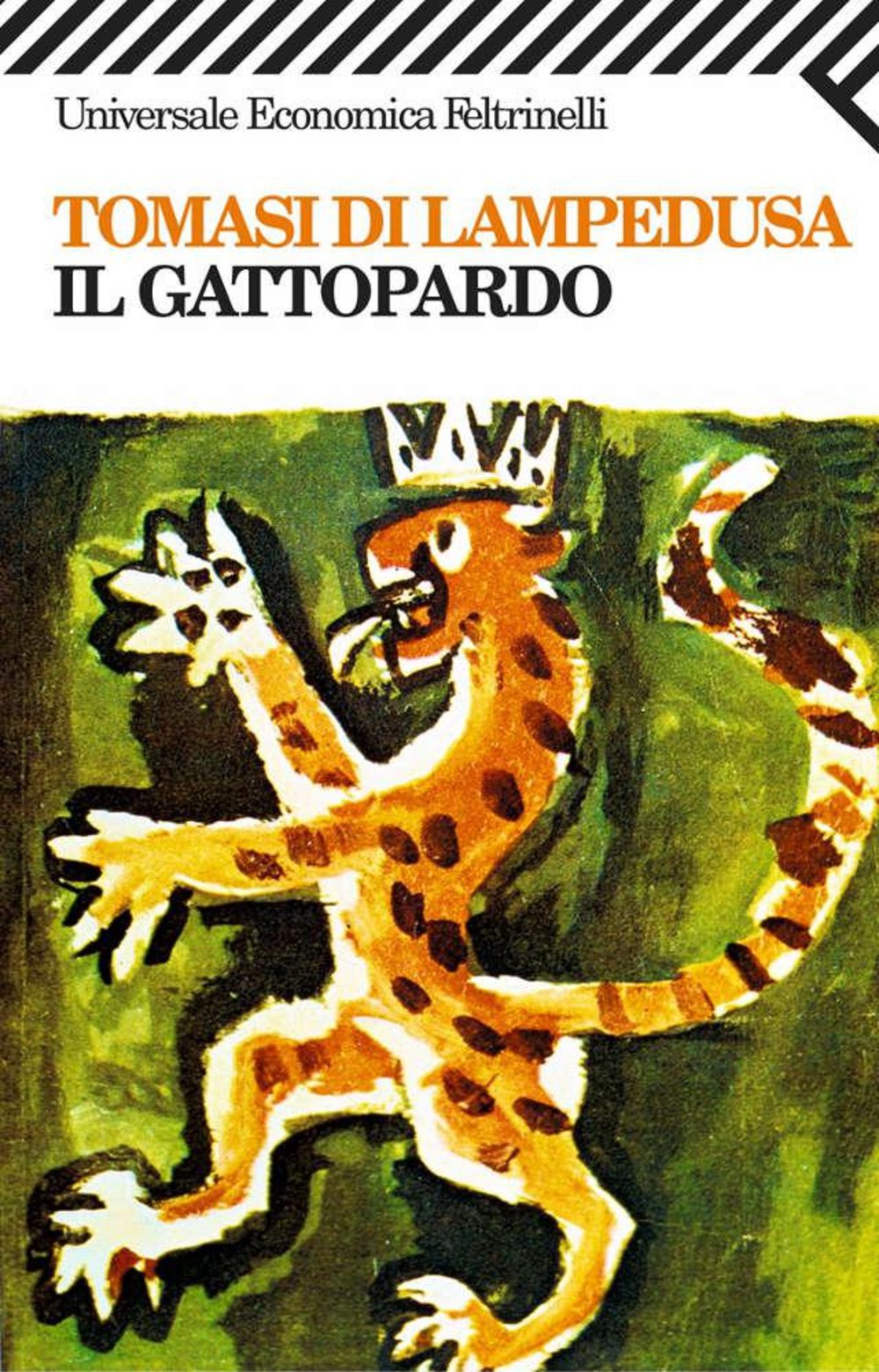
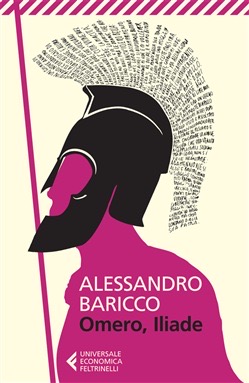
Se all'Iliade togli gli dei, che cosa ti resta? Molto, ma non abbastanza. I poemi omerici ci restituiscono l'immagine che degli dei olimpici avevano i Greci. Erano divinità simili agli uomini ma più forti: una realtà aumentata, senza la quale non capisci perché il tuo destino poggi su avvenimenti talvolta miracolosi, molto più spesso ostili e dolorosi. Ho voluto dedicarmi al volumetto di Baricco per vedere se potessi amare un poema che non sono mai riuscita a leggere, intrecciato com'era di riferimenti eroici nei quali si perdeva l'attenzione, e che trovavo stucchevoli. Ebbene, Baricco non è riuscito nell'impresa, e nemmeno la postfazione, dedicata al sentimento bellico su cui fonda il racconto dell'Iliade, mi ha convinta. Senza gli dei il poema diventa il ripetitivo riproporsi di uomini che odiano uomini e che uccidono, e di eroi che non sono in realtà tali perché provano odio, vanno a combattere, muoiono. Lascio a voi considerare se sia stata un’astuta operazione editoriale per far apparire bello ciò che non lo è. Del resto, se togliete alla tovaglia ricamata il sottile e complesso ricamo, rimarrà pur un finissimo tessuto di lino, ma nessun ornamento. Snaturare il poema in questo modo per permetterne la lettura significa toglierne l'anima.
Ci ho messo un mese a scrivere queste osservazioni, perché dopo aver letto il romanzo di Faulkner, il primo mai letto di questo autore, non sapevo davvero che dire. Vero che avevo forse tentato troppo: il più difficile di tutti dello scrittore americano, il romanzo che Faulkner riteneva il suo capolavoro, e che invece subì l'incomprensione del pubblico e della critica.
Forse non mi aveva convinto l'uso dei salti temporali, del monologo interiore, della focalizzazione interna gestita con i salti di narratore in ogni capitolo: salti che Faulkner voleva fossero resi evidenti dal cambio di colore di inchiostro, ma che le edizioni dell'opera non hanno tenuto presente, per lo meno in Italia.
Eppure, con il progredire dei giorni, la lettura del romanzo ha subito un'evoluzione istintiva: non cercavo più la vicenda, ma come la stessa venisse raccontata. Certo, i fatti erano interessanti, ma chi raccontava era diventato un inevitabile mentitore, perché coinvolto: sarebbe stato il mio compito di lettore vagliare il vero dal falso, e persino dare giudizi sulla voce narrante.
Non so se fosse ciò che Faulkner voleva accadesse, ma mi sono resa conto che il mio istinto di lettore aveva accettato la sfida e si era immerso nelle acque non tranquille del monologo interiore, delle distorsioni sequenziali e temporali, persino del flusso di coscienza se consideriamo il primo capitolo. Certo, la tecnica di Joyce sembrava tutta un'altra cosa, era molto più levigata, accompagnata da una narrazione più articolata e anche più osannata.
Ma nell'Urlo e il furore (che richiama, senza ragione e affinità alcuna, la traduzione in italiano del romanzo di Steinbeck Furore), la decadenza ad un certo punto diventa parola e immagine, con una nitidezza abbagliante. Avrei fatto meglio a prepararmi prima alla lettura, invece di ficcarmici a caso? Non lo so, perché forse non sarebbe successo tutto quanto vi ho descritto, e mi sarei persa la parte più autentica e franca di questa esperienza.


In genere non leggo thriller ma ho potuto apprezzare il genere con questo regalo che mi ha incuriosito. C’è tutta una letteratura costruita sulla suspence (e trame più o meno verosimili) che non possiamo ignorare e ritenere semplicisticamente ‘di serie B’.
Forse nuoce al libro l’ambientazione claustrofobica e la volontà di mantenere tutta la vicenda in un pugno di prolessi e analessi che conducono inevitabilmente a un apertissimo colpo di scena contenuto però nel disporsi banale del finale scontato. Forse i personaggi non sono credibili. Forse l’ambientazione è lacunosa...
Lasciate perdere. Un film con la stessa trama perderebbe moltissimo. Se vi piace il genere, resterete attaccati alle pagine fino alla fine. Se il genere non vi piace, apprezzerete la costruzione serrata dell’intreccio. Dove non c'è la sostanza, almeno c'è la forma. Il che non è poco con la letteratura di oggi.
Se cercate le recensioni di questo titolo sul Web ne troverete di ogni tipo. Noioso, commovente, pregnante, logorroico, confuso, avvincente, ripetitivo, deludente, interessante... un libro su cui ci si può dividere, forse perchè il sottotitolo più opportuno dovrebbe essere: “Come un medico divenne paziente e sperimentò l’incapacità di ascolto dei suoi colleghi”.
E come tale rimane uno dei più bei libri di Sacks, neurologo che noi, non addetti ai lavori, ricordiamo non tanto per le sue teorie sulla proprioricezione, ma per l’appello a porsi in ascolto del paziente, a leggere le informazioni che ne scaturiscono senza buttare via tutto ciò che non deriva da schemi preordinati, ad accettare la quotidianità complessa (tutt’altro che semplice e semplificata) del malato.
Con tutta probabilità Sacks è stato un grande medico perché è stato un grande uomo. Del resto in questo volume possiamo compiere un bellissimo viaggio all'interno dell'animo umano: la serenità, la paura, la speranza, il dolore, la disperazione, l'entusiasmo, l'abbattimento, la curiosità, la nostalgia, la fede, la gioia.. Un incidente e tutto ciò che ne consegue può diventare più che un intreccio, trasformandosi in una vera e propria 'rappresentazione della guarigione', con colpi di scena e battute ad effetto compresi. A mio modesto parere, lo dovrebbe leggere chiunque desideri occuparsi della salute degli altri.
Libro che ho letto per la prima volta tanti anni fa, e che non mi stanco, ogni tanto di riprendere. Questa volta l'ho fatto per i miei alunni di quarta.

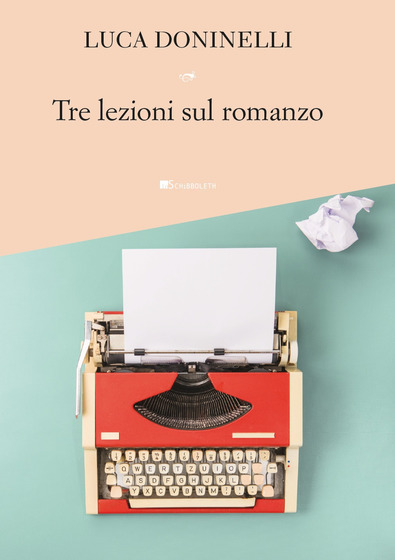
Testo a volte densissimo, talvolta banale. Probabilmente è un saggio, peraltro smilzo, dove l'autore intende celebrare che cosa sia stato il romanzo per lui e per i secoli dove quella forma di scrittura è nata e si è sviluppata in un fiorire generosissimo di opere (secoli XVIII-XX), a fronte di una letteratura che oggi va in un'altra direzione, sia per ragioni di marketing che culturali. Come per un oggetto che sfugge dalle mani, destinato a perire, Doninelli vuole ricordarne la sostanza, la forma, la complessità, le ragioni del successo: il tutto in poche pagine, perché queste non sono lezioni, ad onta del titolo, sono considerazioni, sono riflessioni tra sé e sé. Il romanzo è un arazzo complesso; se non sia ha né il tempo né la capacità di tessere trame complesse quella forma d'arte muore, almeno questo ci dice Doninelli.
Regalerei questo libro? Ora no. Lo userò per le mie lezioni? Forse sì, ma solo in alcune piccole parti. Mi è piaciuto? Abbiate pazienza, non l'ho ancora capito.

Tutto vero, dalla prima parola all'ultima. Voglio dire, chi come me insegna italiano e storia in una scuola del XXI secolo, e magari pure in certi corsi di studio (tipo Meccanica e Meccatronica), troverà nelle pagine della Petri tutta l'ironia necessaria per far fronte alle numerose disfunzioni della scuola italiana, a cui aggiungere l'ormai esplicita convinzione che a scuola non si va per imparare, ma per passare il tempo, trovare amici, acquisire un diploma al termine degli anni passati a dormire, chiacchierare, ruttare, annoiarsi sui banchi delle aule scolastiche. Naturalmente la lettura dell'autrice apre all'ottimistica convinzione che la scuola, soprattutto quella professionale, sia un posto dove regna, nonostante tutto, l'umanità delle persone e il buon senso vinca sempre all'ultimo, come nei film dalle trame più impegnative.
Ultimo (per ora) dei romanzi dedicati al mondo della scuola, dei quali ricordo per primo Ex Cathedra di Domenico Starnone, costruito sullo stesso contesto divertente ma con davanti un orizzonte sarcastico e amaro. E infatti possiamo dire che quel libro, nato circa vent'anni dopo il '68, sia stato una sorta di paletto segnatempo sulla direzione presa dall'istituzione-scuola e da tutte le politiche adottate in questi anni, in un turbinio di riforme che ne hanno fatto un luogo burocratico (per i docenti) e aggregativo (per gli studenti).
Raccontare la scuola a fini ludici oggi è diventata un'attività diffusa. Il romanzo della Petri è, tra questi, uno dei più azzeccati, e quindi complimenti a chi sa scrivere bene (stile efficace, limato, tutt’altro che improvvisato) e bene sa scrivere delle cose che fa. Dubito però che chi lo legga, soprattutto tra i suoi stessi alunni e colleghi, si senta invogliato a cambiare qualcosa: il sorriso prevale, l’ironia cancella l’indignazione, le cose dopotutto vanno bene così.
Il piacere di rileggere

Vengo meno alla regola non scritta di questo mio piccolo diario di idee e letture introducendo il volume di questo post attraverso un titolo riassuntivo: il piacere di (ri)leggere, per l'appunto. Una delle cose più difficili da far passare durante una discussione con gli studenti è che un libro sia bello da prendere in mano anche a distanza (di mesi, di anni) e in quell'occasione avvenga un nuovo incontro. Perché voi le persone le vedete una sola volta nella vita? - chiedo io - ma i miei interlocutori si ritraggono, presi in contropiede, oppure attaccano, decisi a non lasciare sul tavolo del confronto neppure una briciola di dubbio. Io invece posso raccontare che fin da piccola mi piaceva, dopo qualche tempo, riprendere dallo scaffale un romanzo letto tanto o poco tempo prima, per rileggerlo: divertita nel ritrovare ciò che aspettavo, stupita nello scoprire quello che non ricordavo, o forse non avevo visto la prima volta.
Del resto non è così con una canzone, con un brano musicale? Chi va ad ascoltare dei concerti ascolta per lo più sempre gli stessi brani, sempre le stesse canzoni. Chi si mette le cuffiette nelle orecchie e va a correre si aspetta di ritrovare qualcosa di noto, compagno e sprone della sua attività sportiva.
Ogni opera vive quando la si legge, cioè quando quella parla attraverso il lettore: e pur essendo sempre la stessa, ha voci e sfumature diverse a seconda delle persone, dei tempi, delle circostanze. Il suo valore rimane immutato anche se chiusa nel cassetto (un capolavoro di stile, un divertimento di poco conto, una testimonianza sofferta), ma vive solo quando un lettore vi si avvicina e la fa sua. E' come un cibo disidratato: i componenti nutrivi sono lì dentro, ma ci vuole l'acqua per recuperare l'aspetto e la funzione di cibo.
Tutta questa premessa, spero non troppo lunga, si è sviluppata dalla sorpresa di trovarmi tra le mani un piego di libri (ovvero un pacchetto postale contenente libri) speditomi dal mio ex alunno Luca, che ha deciso di studiare una materia che io reputo difficile e per la quale non ho ho nessuna attitudine: Economia. Ebbene, il primo stupore l'ho provato ritrovandomi tra le mani una copia cartacea di Una vita da libraio di Shaun Bythell, che avevo tanto apprezzato alla sua prima uscita nel 2018. E' impossibile non divertirsi a leggere della variegata realtà di clienti che popolano quel negozio di libri usati, così come quando passeggiamo per il microcosmo vastissimo della cittadina di Wigtown, dove l'autore vive e ha aperto la sua attività, o nei brani in cui osserviamo lo stupendo paesaggio scozzese, descritto con immutato stupore. Il tutto in pagine rivestite dallo sguardo autoironico e affettuoso di Bythell.
Insomma, un libro che ho riletto volentieri, e che fa venire voglia, credetemi!, di uscire e andare in libreria, anche solo per incontrare la sua bizzarra impiegata, chiacchierare un po' con lui davanti a una birra, sfogliare uno di quei libri assurdi che però gli fruttano un bel po' di sterline, tutta manna in un'attività che non fa di Shaun Bythell quel che si dice un imprenditore di successo.
Ma ciò che ha dato valore aggiunto a questa rilettura è stato un bigliettino che ho trovato dentro il volume, un bigliettino scritto di proprio pugno da Luca, che ha voluto ricordarmi l'esortazione di Dante/Ulisse a seguire virtute e canoscenza.
Che questo bigliettino fosse dentro un volume come quello di Bythell, pieno di divertiti aneddoti e non certo di citazioni dotte, semmai con molti passaggi che potremmo definire da balordi cazzari, ha illuminato il mio pomeriggio, riportando a galla una rivelazione sempre nuova e sempre stupefacente: la virtù e la canoscenza stanno dovunque ci avviciniamo, con umiltà e curiosità, alle pagine di un libro, e ci mettiamo in ascolto. Nella Biblioteca Ambrosiana, in Università, a casa nostra, o dentro la pittoresca cittadina di Wigtown.
Sapete come va: giornali li per quindici giorni e poi, finalmente, la voglia di leggere un libro, di fare un tratto di strada con qualcuno, è troppo forte. Date le limitazioni autoimpostemi (qualcuno invece aspetta di agire solo con la bacchetta dei dpcm) faccio arrivare il libro direttamente a casa. Questa volta ho seguito il consiglio di un mio ex alunno, che mi ha consigliato uno di quei titoli-must nella scuola degli ultimi anni. Libro che, per le mie note vicende personali, non avevo ancora letto, non troppo ligia alle mode scolastiche. Che dire? Buone intenzioni, vicenda gloriosa, prosa e ritmo per i più giovani, troppa semplificazione per i più grandi. Ma una bella operazione e una lettura godibile, non c’è che dire.


Può un premio Nobel dell'Economia occuparsi di misure atte a promuovere la giustizia sociale e l'uguaglianza in termini di accesso alla ricchezza? Stiglitz lo fa con questo libro, che riporta dati e informazioni precise che potete anche selezionare, se non siete degli economisti come me, per ritenere la tesi di fondo: il fatto che la ricchezza sia nelle mani di una minoranza della minoranza non è solo uno scandalo sociale, ma anche un freno all'econonomia produttiva, che così ristagna a favore delle attività finanziarie. Negli USA il reddito medio del 90 per cento meno ricco della popolazione, al netto dell'inflazione, è stato sostanzialmente stagnante negli ultimi 40 anni, mentre il reddito medio dell'1 per cento più ricco della popolazione è aumentato di 4,3 volte. Questo stesso andamento si è verificato nella maggior parte degli altri Paesi, anche meno in alcuni (quelli scandinavi), mentre in altri (compreso il nostro) analogamente agli Usa. Risultato? Scivolamento in basso della classe media, imprese in sofferenza, servizi pubblici tagliati, tensioni sociali, prospettive senza speranza per le giovani generazioni. A chi pensa che la mano libera del mercato sia tuttora un comandamento inoppugliabile o addirittura che sia l'Economia a dover influenzare la Politica, Stiglitz instilla per lo meno il dubbio, mettendo argomenti e dati al servizio di un ragionamento consequenziale, privo di toni apodittici ma pieno di innegabile passione per la propria tesi.
Ringrazio Luca, futuro economista, per avermi regalato questo volume, dal quale sto estraendo qualche passo per le prove di comprensione del testo argomentativo

Viene descritto come il primo romanzo giapponese moderno, e infatti ciò che spesso fa da sottofondo è la constatazione che l'epoca shogun è finita, la rivoluzione Meiji ha ormai preso piede, e l'Occidente sta entrando, di soppiatto o prepotentemente, nella società giapponese di inizio Novecente. Ovviamente gli occhi del gatto che descrivono la strana famigiia di un professore di inglese di Tokyo e i suoi amici sconclusionati richiamano l'ironia di altri romanzi (Tristam Shandy, Tre uomini e una barca), ma anche la malinconia di una sguardo decadente. Lunghe parti sono noiose e andrebbero saltate a piè pari se non fosse che in mezzo a tanta erba alta si trova anche qualche fiore inusitato. Insomma, un romanzo non per tutti.

Un must, un libro che ogni adolescente deve leggere, per capire quanto possiamo essere schiavi pur credendoci liberi. Non avevo in mente di farlo leggere quest'anno ai miei alunni di seconda liceo, e invece un colloquio con una collega mi ha convinto che era il caso di rivedere i miei programmi e di assegnarlo. Così l’ho aperto di nuovo. È breve, è fin troppo didascalico, ma è sempre avvincente: non puoi smettere di leggerlo, anche se temi di sapere come andrà a finire. Il finale allegro mette malinconia, anzi, paura. Come il migliore dei thriller, solo che qui la paura non è una finzione.

Che cos'è c'è di strano in una mamma single che non ce la fa a vedere nel suo bambino solo una fonte di gioia? Che c'è di azzardato a scrutare i sentimenti di una giovane donna che ritrova nel figlioletto un ladro di energie ed entusiasmo? Il lavoro che ho svolto per vent'anni mi ha fatto incontrare madri di tutti i tipi, quindi il clamore suscitato da questo romanzo non lo capisco proprio. Quanto al libro, poi, a mio parere c'è molto di meglio: costruito su pochi tratti, che invece di dare il senso della claustrofobia interiore regalano piuttosto la sensazione di una povertà e sciattezza creativa.