A.S 2016/17
Premessa: non ho studiato greco, anche se lo sapevo leggere (come la lineare A, ehm ehm). E continuo a incontrare persone che hanno frequentato il liceo classico e che sostengono di avere scelto quella scuola per sottrazione (poca matematica e soprattutto, almeno trent'anni fa, nessuna prova scritta con formule e numeri) piuttosto che per convinzione.
Seconda premessa: anch'io pensavo che Andrea Marcolongo fosse la somma di due nomi maschili. Invece ho scoperto che l'autore è una giovane donna, un po' globetrotter un po' grecista. E soprattutto una bellissima penna: leggere le pagine di questo saggio, dall'intento divulgativo, è piacevole, avvincente, rasserenante.
Rasserenante? Certo. E' quando chi scrive sa essere convincente senza aver bisogno di promuovere nulla. E' quando chi narra vi porge la mano attirandovi nel suo mondo, facendovi capire che può essere anche il vostro. E' quando chi parla trasmette un messaggio talmente allettante che non ha bisogno di essere perentorio, perché chi legge vuole farsene testimone... certo, con le dovute distinzioni. Perché Andrea Marcolongo scrive così dannatamente bene che non credo affatto sia stato merito della Scuola Holden. Se bisogna dare ogni tanto ragione ai solitamente fastidiosi risvolti di copertina, faccio qui volentieri un'eccezione: è vero, questo libro trasuda amore. Amore per la lingua greca, per la civiltà classica, per lo studio inteso come crescita, riflessione, analisi e sintesi. Un amore di cui abbiamo noi tutti (docenti, alunni, operatori culturali, persone pensanti) un bisogno instancabile, e che in queste pagine trova, almeno per un poco, consolazione.

Tutti possono leggere La lingua geniale, senza alcuna vergogna nel saltare la parti in greco, peraltro sempre tradotte dall'autrice. Ovviamente saccheggerò qua e là i paragrafi del testo, dato che, guarda caso, io e i miei studenti stiamo trattando proprio la civiltà greca. Naturalmente sempre con il dovuto rispetto per il Suo lavoro, dott.ssa Marcolongo. Il curioso aneddoto sul Ratto delle Sabine mi ha fatto riflettere: com'è possibile che una giovane ginnasiale come Lei non avesse mai incontrato quell'episodio storico negli otto anni di scuola precedenti? Anche questa appare una bella stranezza, lo sa? Stranezza che spero non si trasformi in monotona regola per le giovani generazioni.

Chi mi segue sa che diffido degli autori nordici, pur amando quelle terre, il clima rigido, la cucina essenziale. Mi devo ricredere con questo romanzo, peraltro annunciato da recensioni lusinghiere e meritate. I personaggi che si intrecciano nella vicenda, di per sé semplicissima pur essendo in realtà complicata (come le gambe della protagonista), appartengono a un mondo fiero e a suo modo fiabesco. E' in questo continuo rincorrersi di realtà straordinaria e di quotidianità che sta la forza della narrazione. Chi termini la lettura sentirà il cuore meno greve, avrà voglia di guardare fuori dalla finestra, di scrivere una mail a un'amica che non sente da tempo, e altre piccole belle cose della vita. Eppure non è un libro minimalista, e neppure banale: è una bella storia, che in quanto tale non chiude nessuna porta davanti al lettore ma semmai la lascia socchiusa, e nel frattempo gli porge il dono prezioso di un libro che lo rende, anche se solo per un attimo, un poco meno infelice.
Evidentemente Natale non è il periodo migliore per le mie letture. Se Fois voleva introdurci a una riflessione antropologica non ci è riuscito: l'idea di partenza è ottima, la costruzione dell'intreccio e le soluzioni narrative sono fiacche. Mi sono permessa di vedere su Anobii alcune recensioni, sperando di non aver capito io e di potermi ricredere: purtroppo ho capito bene, è la Minimun Fax targata Lagioia che si impunta nel proporre scelte sottotono, ma dall'autore "sicuro". Simili scelte sono legittime, per carità, ma in nome di che cosa? Della consueta pallotta dei "nuovi narratori italiani"?


Di questo libro la cosa migliore è la copertina: una scala a chiocciola che vuole significare l'irrealtà di quella protasi (se avessero....) ripetuta all'infinito, eppure reale nei suoi scalini discendenti, verso un punto a cui si arriva ripetendo più volte il movimento circolare.
E' un palese riferimento all'esordio, costruito su un accadimento autobiografico che avrebbe potuto sconvolgere la vita della famiglia Sermonti, ma non l'ha fatto.
Tuttavia la copertina trae in inganno, perché le premesse del risvolto di copertina, approvato senz'altro dall'autore e inteso a dipingere questo libro come una lunga e generosa riflessione su ciò che fu il nostro Paese tra fascismo e antifascismo, si infrangono in un periodare che vuol essere ricercato ma appare invece saccente e contorto.
Lo stile appare decisamente démodé, strizza l'occhio al pastiche linguistico, al monologo interiore, all'ipotassi giocosa di gaddiana memoria, alla complessità della scrittura come mimesi della complessità della vita e del ricordo... Tutto per ottenere una narrazione involuta, eccessiva nel suo ridondante intrecciarsi dei piani temporali e spaziali. Lo sperimentalismo di Sermonti nell'affrontare la vicenda autobiografica è, a mio parere, decisamente fallito: invece del labor limae dello scrittore, ad ogni pagina si avverte un narcisistico mirarsi nello specchio, e al diavolo il lettore. Chi mi merita mi segua, gli altri non meritano.
Se un esordiente si presentasse alla Garzanti con questo manoscritto verrebbe cacciato in fretta: ma di fronte all'insigne letterato non era possibile dire la verità, ovvero che si tratta di un libro purtroppo brutto, che rovina quell'idea di partenza e tutto il successivo dipanarsi narrativo, a cui Sermonti avrebbe potuto offrire ben altro. Forse non ha voluto, per ciò che scrive, per quanto quella vicenda rappresenta: vicenda e ricordi non ancora del tutto sdoganati, e allora figli di un complesso interiore irrisolto piuttosto che di una rievocazione della memoria.
La fascetta del volume è perentoria: L'epopea della grande guerra diventa romanzo. Un po' pretenzioso, no? Come se fino ad oggi romanzi sulla vita in trincea nel 1916 non ce ne fossero stati, e pure opere importanti... In realtà il libro di Biondillo si inserisce a pieno titolo nel solco del romanzo storico di tradizione europea ed italiana: dedicato alla vicenda dell'architetto comasco Antonio Sant'Elia, firmatario quasi per caso del Manifesto dell'Architettura Futurista, ricostruisce gli avvenimenti di anni che videro l'affermarsi di artisti come Carrà, Boccioni, Sironi, Russolo, guidati dal credo futurista di Filippo Tommaso Marinetti. Quest'ultimo fu il più convinto assertore dell'igiene della guerra e il meno coinvolto di tutti nell'epopea al contrario della guerra come merda e sangue, quella che Sant'Elia conosce nella trincea alpina prima come volontario e poi come richiamato alla leva.
Il romanzo poggia su un'ottima ricostruzione storica, e non è necessario leggere la Gratulatoria finale per comprendere l'imponente lavoro di archivio condotto dall'autore. Tuttavia fino a metà dell'opera la scrittura procede quasi didascalica, come se il continuo intrecciarsi di flashback della vita del protagonista sacrificasse il vigore narrativo alla volontà documentaria. E' con l'apparire del dubbio nella mente di Sant'Elia - quel dubbio che smantella le certezze della guerra, della modernità futurista, della stessa verità razionale del progresso - che il romanzo diventa struggente e bellissimo: a significare che lo spirito autentico della narrazione è nel riconoscere la tragedia umana e la menzogna sottesa di chi inneggiava alla guerra come auspicabile scelta di rinnovamento e civiltà.Nella pagine in cui Biondillo indica con chiarezza i mandanti intellettuali della tragedia (Marinetti e Mussolini, ma anche il D'Annunzio di Genova) il romanzo trova la sua ispirazione migliore, perché lo fa senza aggiungere alla Storia nulla più che la sensibilità dello scrittore, e tanto più perché tale sensibilità emerge netta e incontrastata. Dunque il libro è un buon esempio di romanzo storico, nel solco di quella poetica del verosimile che scrittori del calibro di Sciascia e Vassalli hanno saputo perseguire con grandi risultati. Anche Biondillo ha saputo farsene interprete, seppure con qualche esitazione nella prima parte; ma la seconda parte consegna al lettore la certezza di aver letto una bella prova di narrativa, e la sensazione che sulla Grande Guerra sia ancora possibile scrivere molto altro e soprattutto buona letteratura.

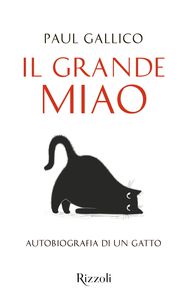
Il Grande Miao di Paul Galliano è l'archetipo (1964) di tutti quei pet-novel che da qualche anno imperversano trasversalmente per case editrici e scaffali di librerie. Questo non ha bisogno di una copertina accattivante perché è, a suo modo, un classico; ma a differenza di quanto il risvolto di copertina vuol far credere, oggi appare un libro sorpassato e senza alcun vigore narrativo.

La Paranza dei bambini è un romanzo dove le donne stanno in seconda fila, e laddove compaiono non si segnalano per una qualche virtù degna di qualche nome, bensì per complicità, ignavia, stupidità. La copertina del volume richiama il culto di una Madonna folklorica e scaramantica, non certo la Madre di Dio. Durante la promozione in TV Saviano ha dichiarato di sperare che le donne si mettano di traverso alla velenosa paranza criminale; tuttavia non si capisce dove collochi il suo auspicio, visto che la mamma di Maraja sa eppure tace, e alla fine chiama persino la paranza alla vendetta.
Il titolo potrebbe essere considerato un Bildungsroman della criminalità napoletana, ma troppi dettagli non tornano: la volontà di descrivere questi ragazzi non come frutto del degrado culturale, ma come funghi impazziti di un humus piccolo-borghese, contamina la verisimiglianza di alcune parti. I genitori del protagonista, lo studente di Liceo Artistico Nicolas Fiorillo, sono un professore di educazione fisica e una piccola imprenditrice: entrambi, nonostante la donna sembri più forte del marito, sono macchiette e non personaggi, non hanno spessore, neppure nella loro inconsistenza. Il fatto che Maraja sia studente sembra funzionale solo al fatto di fargli citare Machiavelli. Lo scorrere del tempo è a tratti confuso, non ben definito: Nicolas parte sedicenne e arriva ai diciottanni, forse anche diciannove, ma nel frattempo che è successo alla carriera di studente che dovrebbe essere stata coerente, visto che al funerale del fratello arrivano i compagni di scuola e il suo professore?
Certo Saviano voleva descrivere il nichilismo che attanaglia questi adolescenti, un nichilismo che si contraddice davanti al lutto o al disonore della famiglia, e in questo l'autore è perfettamente riuscito nel suo intento. Si staglia netta l'immagine di ragazzi che hanno come idolo solo il denaro, il tutto e subito e l'apparenza: a significare che persino il coraggio di fare un pezzo (cioè di uccidere) passa in secondo piano se di quell'impresa omicida si possono vantare altri. Il Machiavelli citato da Maraja si ferma alle frasi che si trovano su Wikiquote, mentre i ragazzini della paranza conoscono a memoria i video di YouTube con le frasi di camorristi e criminali, vessilli culturali ben individuati. L'ossessione di Nicolas per il lusso e l'esibizione criminal-cafona al locale di Posillipo evidenziano una generazione dove la tavola dei valori non è neppure sovvertita, è proprio scomparsa a favore del prendere subito: si va a prendere il denaro (che non è il diventare ricco), ci si prende una piazza (di spaccio) uno spazio (al locale) un nome (tra la criminalità napoletana).
Un romanzo che scali repentinamente le classifiche di vendita e rappresenti un evento letterario e culturale in un Paese dove si legge poco è comunque da apprezzare e da mettere sul piatto buono della bilancia. Da qui a dire che il romanzo di Saviano sia un buon esempio di letteratura ce ne corre: sia per lo stile peculiare dell'autore, che ama la frantumazione sintattica e il ricorso eccessivo alla matrice giornalistica, sia per alcune debolezze dell'intreccio, che si esaurisce in un finale che sembra posticcio rispetto al concatenarsi delle peripezie.

Uno di quei titoli che si devono leggere, ma non si leggono. Al liceo non interessava i miei docenti; all'Università non rientrava tra gli esercizi di ricerca filologica e critica; in seguito il titolo è rimasto nel cassetto dei classici contemporanei, citato e mai preso in mano... Ho rimediato in questi giorni, perché per i miei studenti di quinta sto preparando le lezioni sulla Prima Guerra Mondiale. Fatto curioso, dalla Resistenza alla Prima Guerra mondiale il passo è breve se si pensa che Lussu scrisse l'opera nel 1938, mentre era in esilio e su esortazione di Gaetano Salvemini.
Il libro è bellissimo. Quando Mario Rigorni Stern afferma che è il migliore tra tutti i libri sulla Prima Guerra Mondiale non esagera. L'opera è uno sguardo nitido e lucido sulle vicende di quella guerra di trincea e di montagna, un racconto ben rappresentato e soprattutto ben meditato. Mi ha colpito particolarmente lo stile, che risale al 1938 ma mostra un'asciuttezza elegante e una assoluta mancanza di retorica. E' prosa limpida, senza alcun intoppo, senza alcuna concessione alla ridondanza. Sapeva ben scrivere Lussu, altro che! Molto più di altri più blasonati suoi contemporanei... La lettura non presenta difficoltà se solo evitate di seguire i gradi gerarchici dei raggruppamenti militari, sui quali ho subito alzato bandiera bianca. Ma anche così non si perde nulla: "Un anno sull'altipiano" è un libro di guerra, sulla guerra, che muove dalla guerra per parlare della stupidità degli uomini e della solidarietà umana.
L'ho letto abbinandolo alla visione del film di Mario Monicelli "La Grande Guerra": un film da vedere, ad ogni costo. Una prova intelligente e piena di garbo, che si fa rimpiangere..

Molto spesso i saggi storici non ci appassionano, li inseriamo nella casella "lavoro/studio" invece di quella "piacere". Invece, tanto per richiamarmi al titolo, ho voluto fidarmi di una semplice indicazione bibliografica per ritrovarmi sul comodino una bella sorpresa. Il libro di Rusconi è dedicato ai mesi che precedettero la dichiarazione di guerra del maggio 1915, al sottile gioco di relazioni diplomatiche, rapporti militari, contraddizioni, verità asserite e poi smentite, che segnarono la decisione di entrare in guerra contro l'Austria a fianco della Triplice Intesa. Il libro si legge come se fosse un legal thriller, con l'aggiunta della verità storica che l'autore ha ricostruito con pazienza e grande lucidità narrativa. Una scelta di cui non mi sono pentita, un'altra scoperta felice che consiglio a chi voglia indagare su come l'Italia decise la sua guerra. I riferimenti alle "radiose giornate di maggio" sono appena accennati: a Rusconi interessa l'analisi politica di quegli anni, in Europa e in Italia. Giustamente Mario Isnenghi ha scritto che si tratta di un libro "controcorrente e spiazzante, e tutto da leggere". Ma l'essere controcorrente è tutt'altro che eccentrico, bizzarro e dilettantistico. L'analisi di Rusconi è dannatamente precisa e pacata, intessuta sulle numerose citazioni dai documenti del tempo, e seguita da un breve ma interessante riferimento a ciò che accadde nell'Italia del 1939.

Non credo mi bastino poche righe per considerare il valore di "La Storia" di Elsa Morante. Il libro è corposo e denso, e per me è stata una scoperta autentica. A leggere le annotazioni critico-letterarie odierne, certo non numerose, il romanzo provocò un intenso dibattito ideologico. La vicenda e la narrazione si discostavano dai dettami marxisti della lotta di classe; i padroni e gli sfruttatori apparivano lontani, e gli stessi proletari diventavano carnefici (Nino passa da fascista a partigiano a contrabbandiere; il perseguitato Davide Segre da orfano a tossicodipendente che tratta male lo sparuto Useppe).
Eppure, se oggi devono bastare poche parole di fronte alle 630 pagine del romanzo, La Storia è un libro che non può passare inosservato. Alcune parti sono scritte con uno stile asciutto e nitido, altre sono prolisse e irritanti. Certi passaggi sembrano essere costruiti per imprimersi nella memoria, a fronte di paragrafi interi dove non aspetti che di cambiare scena. Ma la sostanza resta, tesa sul concetto che fa da leitmotiv a tutto il libro: dietro ogni esistenza, anche la più insignificante all'apparenza, c'è una storia che racchiude vicende grandi e potenti. La tessitura degli eventi che ricordiamo nei manuali scolastici lacera e intreccia queste vicende, ma non può oscurare la loro forza, anche se sono destinate a cedere al comune destino della morte.
A pelle sembra che vinca il senso della sconfitta, che tutta la Storia, e con essa le storie dei protagonisti del romanzo, sia destinata alla sonfitta. Se Useppe, Ida, Nino, Davide, Bella e Blitz sono disgraziati immersi in un mondo infelice, non c'è nessuno che si salvi: altri disgraziati, solo apparentemente meno sfortunati, si determinano ad essere attori di infelicità. Dove siamo noi, che facciamo? Sono così lontani Useppe, Ida, Davide? Siamo così lontani noi?
Ma il libro, come ben sostiene l'introduzione di Cesare Garboli, non è una noiosa litania di sventure. La Storia è anche un romanzo sorridente, un'opera dove a tratti senti di amare la Vita, qualunque essa sia: caparbia, tenace, testarda, che a suo modo si permette perfino di prendersi gioco del dolore e della morte. Ed è questa leggerezza rasserenante che convince il lettore a proseguire per le 630 pagine dell'opera.
Mi vien da pensare che solo una donna poteva scrivere un simile romanzo... o forse no, ma di questo parlerò un'altra volta.
Thomas Bernhard è uno scrittore che o piace o si detesta. Io lo prediligo perché la sua scrittura, d'istinto difficile e respingente, è in realtà un potente atto d'amore per l'intelligenza, la lucidità dei sentimenti, la solidarietà del sentire umano. Il fatto che questo autore si sia inimicato larghi strati di pubblico e di critica con affermazioni quali "gli austriaci tengono al caldo la loro ottusità" è la controprova di simile com-passione per il destino degli uomini, tragica e spesso senza risposte al dolore, e perciò priva di ogni affettazione in perdite di tempo retoriche e concettuali. Bernhard sapeva che non avrebbe vissuto a lungo, la sua malattia cronica fu il frutto di uno sciagurato e ostinato errore medico: qualcuno può ritenere superficialmente che la scrittura cupa e aspra sia un disporsi ossessivo e arrabbiato di pensieri, mentre in realtà è un doloroso richiamo alle cose autentiche, senza le ipocrisie di contorno, frutto di un gesto persino generoso da parte di chi non solo si sentiva ma era in credito con la Vita. Per leggere "I mangia a poco" (definizione attribuita a un gruppo di commensali che sceglie il menù economico in locale popolare di Vienna) ho dovuto insistere, come spesso nei libri di Bernhard: non disperate se le prime 10-20 pagine sembrano ricusarvi, continuate e ad un certo punto sarete sintonizzati sul tono, stilistico e di contenuto, dell'autore. Il grande merito di Bernhard, a mio parere, è andare in profondità con la massima indifferenza, senza farci capire in quale abisso ci siamo inoltrati fino a quando, d'improvviso, una delle sue constatazioni fulminanti non ce lo fa percepire. Se il protagonista Keller sia pazzo o meno non è importante, quello che ci importa è quanto la maniacale pazzia di quest'uomo, fin dalla giovinezza segnato dalla diversità, riesce a divenire voce corale. Molti in Bernhard non scorgono questa coralità, ma solo contrapposizione, astio, persino odio. Io invece credo che Bernhard abbia espresso la voce, splendida e scomoda, di chi scrive senza dover fare i conti con l'accettazione sociale: sapendo che in realtà li farà questi conti, che dovrà affrontare un prezzo anche alto, ma che solo in questo modo riuscirà ad essere interprete autentico di una letteratura senza infingimenti: Da parte mia, però, non avevo mai pensato neanche per un attimo di sottrarmi a lui, cosa che probabilmente non mi sarebbe nemmeno stata possibile, io infatti lo capivo e lui, anche quando era insopportabile e intollerabile, era una persona a me vicina.


Sarà possibile, nel futuro immediato, leggere, parlare di libri, essere cultori di letteratura? Forse la narrativa e più in generale la letteratura saranno ingurgitate dal prolisso gorgo magmatico dei social. I personaggi come Ottavio Tondo, puri lettori, non la spunteranno su chi scrive per offendere, insultare, umiliare, spiare le vite altrui e distruggerle con le parole. Da Loretta Bui, l'acida critica letteraria che raggiunge la notorietà demolendo le opere di ogni scrittore, ai frequentatori dei social: ormai non si legge più, si scrive e basta, e lo si fa non per allargare i propri orizzonti, ma solo per restringerli in una dimensione nichilista. Un libro molto ben scritto, anche se, a mio parere, non sempre ben congegnato nella fabula. Pagine che fanno riflettere, e molto seriamente, senza alcuna pesantezza o infingimento accademico.
Davanti al prof. Serianni occorre alzarsi in piedi, salutare con deferenza, e ascoltare attentamente. Ma non c'è nulla di veteroaccademico in questo volumetto, agile e breve quanto utile e ben strutturato. Proprio per tutti, come recita la quarta di copertina? Non direi: alunni e genitori lo troverebbero troppo tecnico. Da parte mia non condivido proprio tutto; ma ho trovato interessante ogni riga del testo.
Libro che si legge in fretta e si rilegge con calma.

"Il più saviniano tra i libri di Savinio" leggo nella postfazione a questa raccolta di racconti. Dovrei trovarci (a detta della curatrice, delle recensioni, dell'autore stesso) impegnato surrealismo civico, abbondante ironia, ariosa creatività per combattere la lugubre dittatura della politica e delle idee... sinceramente non ho trovato nulla di tutto ciò. Interessante a tratti la scrittura, che talora s'avvolge in un negligé d'avanguardia storica, talora in un colore d'interni ottocentesco. Ma il libro è davvero deludente. L'unico racconto che vale la pena di leggere è "Paterni mobili", purtroppo sciupato nel finale sciatto e affrettato. Tutto il resto è noia, e desta stupore pensare che l'autore abbia preteso di vincere il Viareggio 1946 con questo testo: non certo perché è un'opera "troppo avanti" o "troppo diversa", ma semplicemente perché appare poco ispirata e ripetitiva

Furbizia editoriale, dato che il breve racconto è stato cucito tipograficamente ad arte (risguardi, pagine bianche, diversi occhietti) per farne un volumetto gonfiato a 84 pagine (e 10 euro). Nutro profondo rispetto per questo autore di successo, anche mediatico, e dalla scrittura coraggiosa per il nostro panorama culturale; ma operazioni come queste tolgono la voglia di leggerlo. La storia è carina, nello stile della Trinacria di Camillieri, ma non merita un titolo a parte.
DAVIDE ZARDO - VIGEVANO ROSSO DUCALE

Chi legge questo romanzo potrà non essere d'accordo sull'operato del commissario Demetrio Spada, vendicatore suo malgrado di una giunta che respinge lo straniero fino a quando non si tratta di affari. Ma di una cosa si può essere certi: Davide Zardo sa fare bene il mestiere di scrittore, e in questo libro lo dimostra senza tentennamenti. Sia che si confronti con la grigia poesia del paesaggio lomellino o con le alterne e composite voci dei personaggi, la sua prosa è sempre curata ed esatta, senza le sbavature che una vicenda come quella raccontata poteva finanche giustificare, visto il tuffo smaccato nel riconoscibile côté vigevanese. Se il fantasma di Beatrice d'Este aleggia su di un complicato intreccio di omicidi e corruzione, la concretezza dell'impianto narrativo prende il lettore per mano e lo immerge senza incertezze nella cupezza del rosso sangue, anzi, del Rosso Ducale. Ma i fantasmi di cui ci parla Zardo non sono solo quelli che si appellano all'incredulità dei molti. Sono le voci che attraversano l'anima del commissario Spada, e che cercano di rimarginare una ferita d'amore; sono il farsi e disfarsi degli eventi, impietosi finché la soluzione si impone a non risolvere nulla; sono gli incubi di una città che vive di pettegolezzo e muore nella paura, di sé o dell'altro questo non è dato fino in fondo capire.

